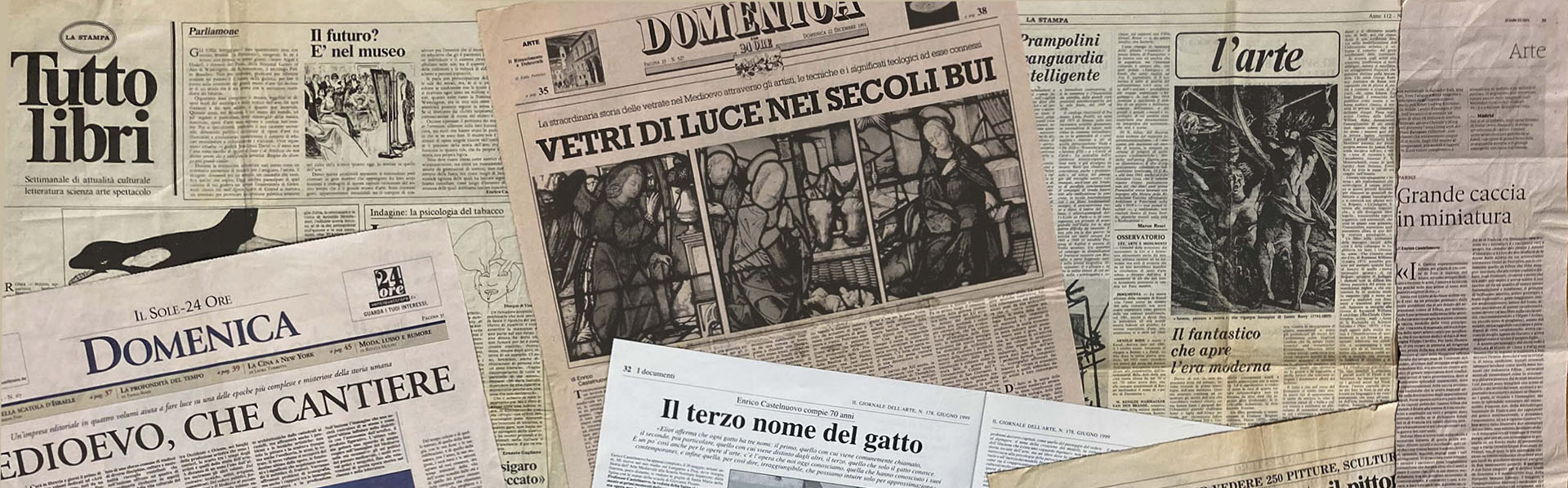Sfoglia documenti (77 in totale)
-
Piccolo tour tra le botteghe di Carinzia
Recensione della mostra: Schauplatz Mittelalter Friesach (Friesach, Fürstenhof, 28 aprile-28 ottobre 2001). Castelnuovo torna sulle Landesausstellung, le esposizioni nazionali promosse dai Länder della Germania e dell'Austria, su cui si era già soffermato l’anno precedente, in occasione dell’inaugurazione di 1500 circa. Landesausstellung 2000 Mostra storica (20 agosto 2000). L’edizione del 2001 tenuta a Friesach, capoluogo della regione della Carinzia e antico polo commerciale del principato degli arcivescovi di Salisburgo, è dedicata alla città nel medioevo e indaga da differenti punti di vista, attraverso documenti, manufatti e opere d’arte, la vita quotidiana negli insediamenti urbani tra XI e XV secolo.
Una copia del catalogo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Nello scrigno di Re Luigi
Recensione mostra: Le trésor de la Sainte Chapelle (Parigi, Museo del Louvre, 31 maggio 2001-27 agosto 2001) catalogo edito dalla Réunion des Musées nationaux. Castelnuovo ripercorre le vicende della Sainte Chapelle di Parigi, eretta da Luigi IX per conservare il tesoro di reliquie acquistate da Costantinopoli, dalla fondazione sino alla dispersione delle opere durante la Rivoluzione, soffermandosi su alcuni dei capolavori di arte suntuaria e miniatura commissionati dalla famiglia reale. L’articolo richiama alcune mostre affini a quella in corso:- Le trésor de Saint-Denis (Parigi, Musée du Louvre, 12 marzo-17 giugno 1991), catalogo edito dalla Reunion des musees nationaux;
- The Treasury of Basel Cathedral (New York, Metropolitan Museum of Art, 28 febbraio-27 maggio 2001; Basilea, Historisches Museum Basel, 13 luglio-31 ottobre 2001), catalogo edito dal museo e dalla Yale University press.
-
Torino, riapre Palazzo Madama
Recensione della mostra: Tra Gotico e Rinascimento. Scultura in Piemonte (Torino, Museo Civico d’Arte Antica, 2 giugno-4 novembre 2001), a c. di Enrica Pagella, catalogo edito dalla Città di Torino.
Castelnuovo presenta gli eventi promossi per la parziale riapertura al pubblico del Museo Civico d'Arte Antica di Torino, dopo la chiusura della sede di Palazzo Madama nel 1988: l’intervento di restauro dell’atrio e dello scalone di Filippo Juvarra, lo scavo archeologico della corte medievale e, soprattutto, la mostra della scultura in Piemonte tra il Duecento e il Quattrocento, con opere del museo e del territorio. L’articolo si concentra sulle sculture lignee in rassegna, facendo emergere i principali centri del Piemonte, spesso punto di incontro di influenze e artisti di diverse origini, ed i committenti più rilevanti. Non manca di ricordare il giudizio di Luigi Lanzi sul Piemonte, descritto come terra di confine colpita da guerre e pertanto priva di una scuola pittorica antica, (tratto dalla prima edizione della Storia pittorica della Italia, tomo secondo, parte seconda, p. 348), ricordando alcune mostre affini a quella in corso:- Gotico e Rinascimento in Piemonte. 2° Mostra d’arte a Palazzo Carignano (Torino, Palazzo Carignano, 1939), a c. da Vittorio Viale, catalogo edito dalla Città di Torino;
- Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale (Torino, Palazzo Madama, aprile-giugno 1979), a c. di Enrico Castelnuovo e Giovanni Romano;
- Il tesoro della città. Opere d'arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama (Stupinigi, Palazzina di Caccia, 31 marzo-8 settembre 1996), a c. di Silvana Pettenati e Giovanni Romano, catalogo edito da Allemandi.
Una copia del catalogo e degli altri in evidenza sono presenti nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”.
-
L'eroe dei due mondi si chiamava Dürer
Recensione dell’opera: Heinrich Wölfflin, L’arte del Rinascimento. L’Italia e il sentimento tedesco della forma, a c.di Maurizio Ghelardi, Livorno, Sillabe, 2001. Castelnuovo elogia il progetto editoriale, che a sessant’anni dalla pubblicazione di Die Kunst der Renaissance. Italien und das deutsche Formgefuhl (Buckmann, 1931) ne offre la prima traduzione italiana. L’articolo fornisce coordinate sul contesto in cui è maturato questo studio comparativo sul rapporto tra arte tedesca e arte italiana tra il 1490 e il 1530, ripercorrendo i principali studi di Wölfflin per meglio contestualizzarne l’opera:- Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien, Monaco, Theodor Ackermann, 1888 (I ed. italiana: Rinascimento e Barocco. Ricerche intorno all'essenza e all'origine dello stile barocco in Italia, Firenze, Vallecchi, 1928);
- Die Kunst Albrecht Dürers, Monaco, Bruckmann, 1905 (I ed. italiana: Albrecht Dürer, Roma, Salerno, 1987);
- Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, Monaco, Bruckmann, 1915 (I ed. italiana: Concetti fondamentali della storia dell'arte. La formazione dello stile nell'arte moderna, Milano, Longanesi, 1953).
-
Il Candelabro Trivulzio? Un bel tenebroso
Stralcio dell’intervento I misteri di un candelabro redatto da Castelnuovo per Il candelabro Trivulzio nel Duomo di Milano (Milano, Silvana editoriale, 2000; una seconda emissione fuori commercio è pubblicata per il Credito Artigiano di Milano).
Castelnuovo torna con la memoria a una delle esercitazioni di Roberto Longhi sul candelabro Trivulzio, durante gli studi di perfezionamento all’Università di Firenze (1951-1955), ricordando che allora nessuno dei partecipanti era riuscito a identificarlo. Con questo episodio intende mostrare quanto poco si sapesse di quest’opera prima dell’indagine di Fulvio Cervini, cuore del volume, nonostante la sua collocazione pubblica nel Duomo di Milano sin dal Cinquecento (Castelnuovo richiama anche il fascicoli su Nicolas de Verdun de I maestri della scultura, curato nel 1966, dove nelle didascalie non era riuscito a specificare l’ambito di provenienza). A partire da queste esperienze personali, è introdotta la disamina di Cervini (Alberi di luce. Il Candelabro Trivulzio nella cultura medievale) che fa luce sull’origine, sulla funzione, sul programma iconografico e sui legami con opere affini al candelabro Trivulzio.
Il contributo è introdotto dalla presentazione di Marco Carminati. -
Tempeste iconoclaste
Recensione della mostra: Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? (Berna, Bernisches Historisches Museum, 2 novembre 2000-16 aprile 2001; Strasburgo, Musée de l'Œuvre Notre-Dame, 12 maggio-26 agosto 2001), a c. di Johannes Tripps. Castelnuovo torna sul tema del valore simbolico e degli usi delle immagini sacre, presentando il fenomeno della rimozione e distruzione delle opere durante i moti iconoclasti della Riforma protestante. L’esposizione nasce, appunto, dal ritrovamento di un gruppo di sculture, sepolte in quel periodo turbolento, negli scavi attorno alla Collegiata si San Vincenzo di Berna, per indagare quale significato e quale potere evocativo queste opere abbiano avuto sugli uomini di quel tempo.
Nell’articolo sono menzionate, vista l’impostazione affine, le mostre Sacre passioni. Scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 8 novembre 2000-8 aprile 2001), recensita da Castelnuovo il 12 novembre, e Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum, 31 maggio-8 ottobre 2000), da lui presentata il 17 settembre. -
«Mecenati e pittori» nella Roma barocca
A un anno dalla scomparsa, Castelnuovo traccia un profilo di Francis Haskell (1928-2000) in occasione della pubblicazione della terza edizione italiana di Mecenati e pittori. L'arte e la società italiane nell'età barocca (Allemandi, 2000; I ed. it. Sansoni, 1966; I ed. Chatto & Windus, 1963) e dell’opera postuma The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition (Yale University Press, 2000). Ne presenta il suo personale approccio alla storia dell’arte, orientato alla ricostruzione del rapporto delle opere e degli artisti con il loro contesto storico e culturale di provenienza e sulla loro ricezione da parte del pubblico attraverso i secoli.
A tal proposito, Castelnuovo ricorda alcune delle principali pubblicazioni di Haskell:- Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France, Londra, Phaidon, 1976 (Riscoperte nell'arte. Aspetti del gusto, della moda e del collezionismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1982);
- Arte e linguaggio della politica e altri saggi, Firenze, SPES, 1978;
- Past and present in art and taste, New Haven-Londra, Yale University Press, 1987 (in italiano, Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1987);
- History and its images. Art and the interpretation of the past, New Haven-Londra, Yale University Press, 1993 (Le immagini della Storia. L’arte e l’interpretazione del passato, Torino, Einaudi, 1997).
L’articolo preannuncia l’uscita della bibliografia dei suoi scritti (Francis Haskell. A Bibliography, in «Saggi e memorie di storia dell'arte, 23 (1999), 223-274», a c. di Linda Whiteley) e la pubblicazione dei testi delle Lezioni Comparettiane tenute da Haskell alla Scuola Normale Superiore nel 1999 (Antichi maestri in tournée. Le esposizioni d'arte e il loro significato, a c. di Tomaso Montanari, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001; l’opera è recensita da Castelnuovo nel 2002).
Una copia di gran parte delle opere citate è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Infiammati dai legni devoti
Recensione della mostra: Sacre passioni. Scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 8 novembre 2000-8 aprile 2001), a c. di Mariagiulia Burresi, catalogo Federico Motta Editore. Lo stesso Castelnuovo scrive un contributo nel catalogo: Andrea Pisano scultore in legno (pp. 152-163).
Castelnuovo ritorna sulla scultura lignea nella Toscana tra XIII e XIV secolo, tema su cui era già intervenuto nelle recensioni alle mostre Scultura dipinta. Maestri di Legname e Pittori a Siena (1250-1450) (Siena, Pinacoteca Nazionale, 16 luglio-31 dicembre 1987, a cura di Alessandro Bagnoli) e Scultura lignea a Lucca 1200-1425 (Lucca, Palazzo Mansi, Villa Guinigi, 16 dicembre 1995-30 giugno 1996, a c. di Clara Baracchini). Se in queste occasioni aveva toccato questioni come la fortuna critica e l’avvio degli studi sulla scultura lignea, i censimenti promossi dalla Soprintendenza pisana, il rapporto tra pittori e scultori e le modalità di produzione, seguendo l’impostazione dell’esposizione ora il focus si sposta sul problema della fruizione di queste opere da parte dei fedeli, a partire dal sentimento religioso che li animava.
Nell'articolo sono richiamate le ricerche di Géza De Francovich, L'origine e la diffusione del crocifisso gotico doloroso («Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana», 1938) e Scultura medievale in legno (Tumminelli, 1943), e due due mostre del dopoguerra che hanno contribuito all’avvio degli studi sulla scultura lignea:- Mostra dell'antica scultura pisana (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, luglio- novembre 1946), catalogo Riccardo Barsotti editore.
- Mostra dell'antica scultura lignea senese, (Siena, Palazzo Pubblico, luglio- settembre 1949), a c. di Enzo Carli, catalogo Electa; proprio a Carli è dedicata la mostra Sacre passioni.
-
Piccoli capolavori da camera (da letto)
Recensione della mostra: Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum, 31 maggio-8 ottobre 2000), catalogo a c. di Frank Matthias Kammel. Castelnuovo si sofferma sull’impostazione dell’esposizione, che indaga il fenomeno dei dipinti, delle sculture e in generale dei manufatti destinati alla devozione privata durante il Trecento e il Quattrocento, presentando i soggetti, la loro diffusione e la ricezione, il loro valore simbolico e l’uso delle immagini nella preghiera. Nell’articolo sono anche menzionati il volume di Jeffrey F. Hamburger, Nuns as Artists. The Visual Culture of a Medieval Convent (University of California Press, 1997) e l’Autunno del Medioevo di Johan Huizinga.
Una copia del catalogo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Ritratto in tondo di Macrino d'Alba
Recensione dell’opera: Edoardo Villata, Macrino d’Alba, presentazione di Giovanni Romano, Alba, Fondazione Ferrero, 2000 (stampa: Editrice Artistica Piemontese).
Castelnuovo introduce la produzione e la fortuna critica di Macrino d’Alba, con particolar riguardo al confronto col suo contemporaneo Gandolfino di Roreto, soffermandosi sul legame con Pinturicchio e sui modelli di riferimento, sull’apporto del viaggio a Roma e sui committenti, in particolare la corte dei Paleologi. L’articolo attacca ricordando la recensione di Bortolo Ghineri, anagramma di Roberto Longhi, alla monografia dedicata da Giovanni Bistolfi al pittore: Macrino d’Alba. Appunti su la vita e le opere di un pittore piemontese del secolo XV, Torino, Lattes, 1910 (Macrino d’Alba, «Piemonte», 29 dicembre 1910, riedito in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, VIII.1, Fatti di Masolino e di Masaccio e altri studi sul quattrocento 1910-1967, Firenze, Sansoni, 1975, p. 180).
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”.