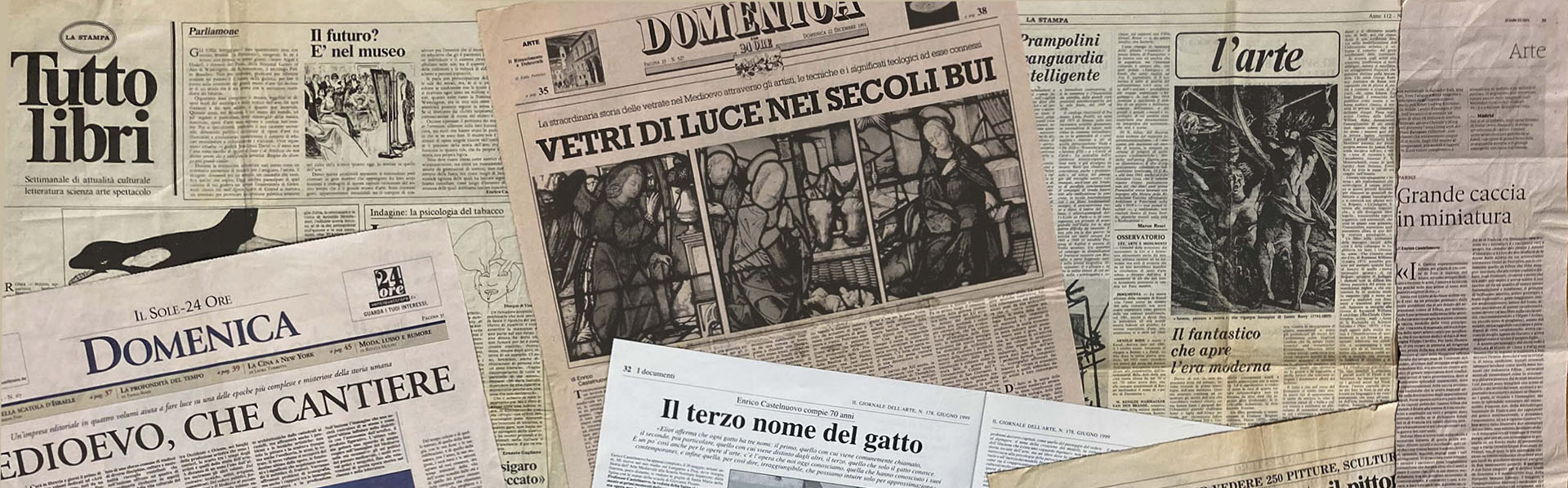L’800 non fu poi così stupido
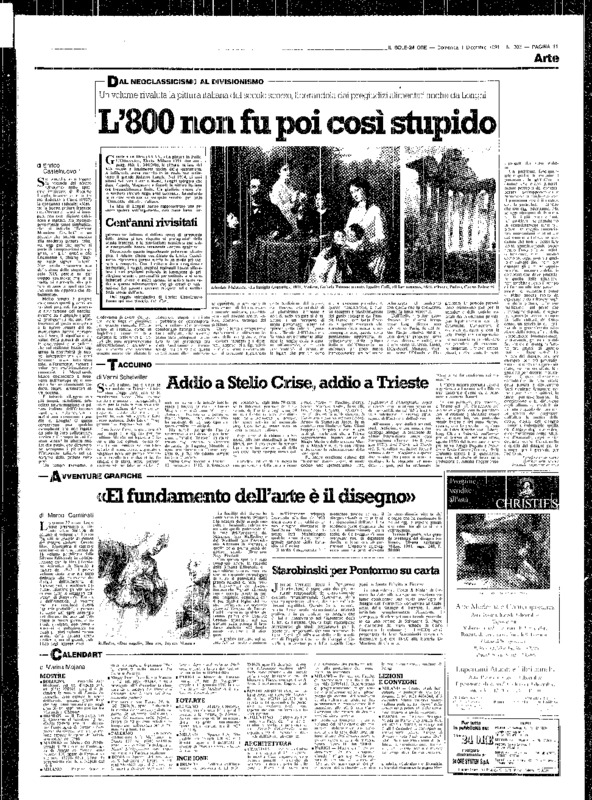
- Titolo
- L’800 non fu poi così stupido
- Descrizione
- Stralcio della prefazione redatta da Castelnuovo per La pittura in Italia. L'Ottocento (a c. di Enrico Castelnuovo, Milano, Electa, 1990, 2 voll.; un’edizione ridotta e fuori commercio è edita lo stesso anno per la Banca Nazionale dell’Agricoltura). Partendo dalla rievocazione della sfortuna critica della pittura dell’Ottocento italiano, in particolare dal giudizio di Roberto Longhi, sono delineati i criteri e le nuove prospettive adottati nell’opera. Per la stessa collana Castelnuovo aveva già curato i due volumi sul XIII-XIV secolo, pubblicati nel 1986 (La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento). L’articolo è introdotto da un trafiletto di Marco Carminati, a cui probabilmente si deve il lavoro redazionale.
Per il giudizio di Longhi cfr. Carlo Carrà, Milano, Hoepli, 1937, riedito in Opere Complete, vol. XIV: Scritti sull’Otto e Novecento, Firenze, Sansoni, pp. 39-46: “Mentre la buona pittura francese dell’Ottocento quasi s’inaugura con quel dipinto calcinoso ed ingrato, ma inconsapevolmente tanto simbolico, che s’intitola: «Bonjour, M. Courbet», è un peccato che ancora manchi alla moderna pittura italiana, oggi poi che molto si parla di composizioni a soggetto, un gran quadro che finalmente si chiami: «Buona notte, Signor Fattori». Non credo, insomma, alla definizione dello «stupido secolo XIX» perché mi par troppo estensiva; ma se si tratta di riservarla alla pittura italiana di quel centennio non mi opporrò che debolmente” (p. 39).
Una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. - Autore
- Enrico Castelnuovo
- Autore di contributo subordinato
- Marco Carminati
- Fonte
- Il Sole 24 Ore, anno 127, n. 306, p. 31 (inserto Domenica)
- Editore
- Il Sole 24 Ore; digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino (2023)
- Data
- 1991-12-01
- Gestione dei diritti

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale- Relazione
- Inventario del fondo Enrico Castelnuovo, unità archivistica «Il Sole 24 Ore» (Archivio storico dell'Università di Torino)
- Formato
- application/pdf
- Identificatore
- Sole_1
Collezione
Etichette
Citazione
Enrico Castelnuovo, “L’800 non fu poi così stupido,” Enrico Castelnuovo sulla carta stampata, ultimo accesso il 18 maggio 2025, https://asut.unito.it/castelnuovo/items/show/1.