Il cantiere medioevale
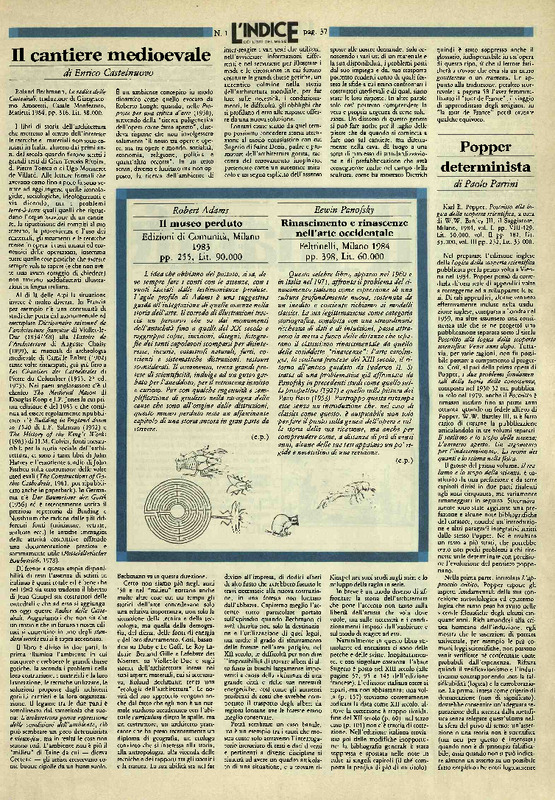
- Titolo
- Il cantiere medioevale
- Descrizione
- Recensione dell'opera: Roland Bechmann, Le radici delle cattedrali. L'architettura gotica espressione delle condizioni dell'ambiente, Casale Monferrato, Marietti, 1984 (I ed. Les racines des cathédrales. L'architecture gothique, expression des conditions du milieu, Parigi, Payot, 1981). Sottolineando come gli studi di storia dell’architettura in Italia non abbiano, per tradizione, indagato le questioni pratiche del costruire, quali le tecniche, l’organizzazione del cantiere e i materiali, Castelnuovo si focalizza su questi aspetti del libro, qui indagati con particolare attenzione al contesto di produzione (ovvero l’ambiente, come suggerisce il sottotitolo) in cui si é fiorita l’architettura gotica.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. - Autore
- Enrico Castelnuovo
- Fonte
- L’Indice dei libri del mese, anno 1, n. 1, p. 37
- Editore
- L'Indice dei libri del mese; digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino (2025)
- Data
- 1984-10 (ottobre)
- Gestione dei diritti

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale- Relazione
- Inventario del fondo Enrico Castelnuovo, unità archivistica «L'Indice dei libri del mese» (Archivio storico dell'Università di Torino)
- Formato
- application/pdf
- Identificatore
- L'Indice_1
Collezione
Citazione
Enrico Castelnuovo, “Il cantiere medioevale,” Enrico Castelnuovo sulla carta stampata, ultimo accesso il 13 agosto 2025, https://asut.unito.it/castelnuovo/items/show/162.

