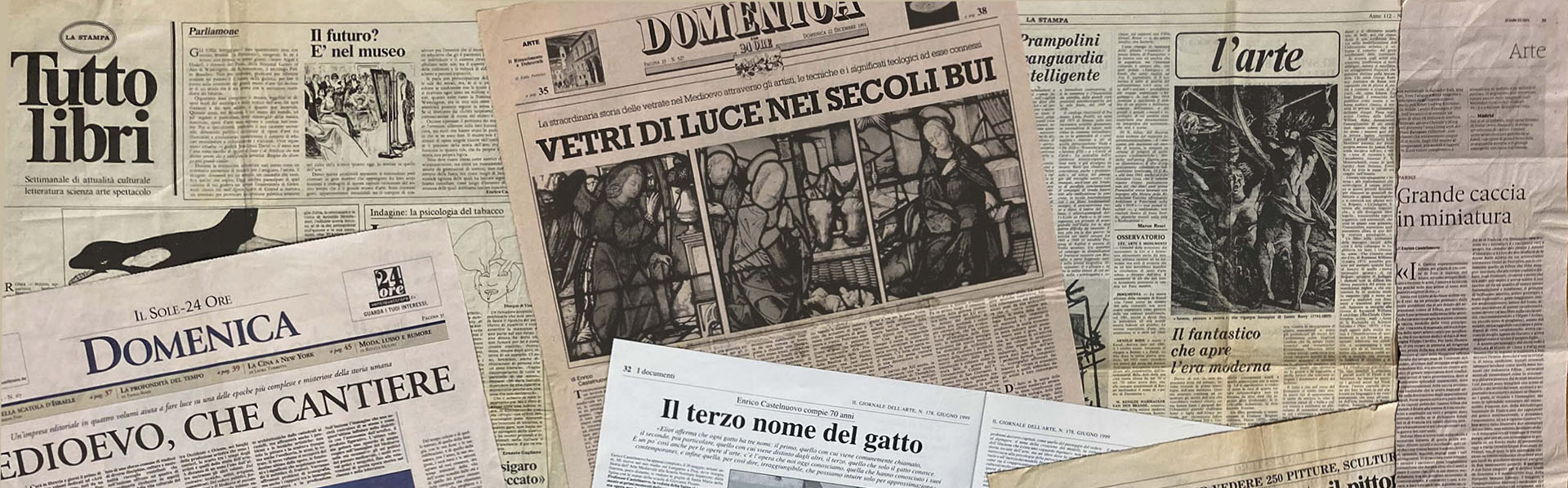Gli sbalzi di lucchesia
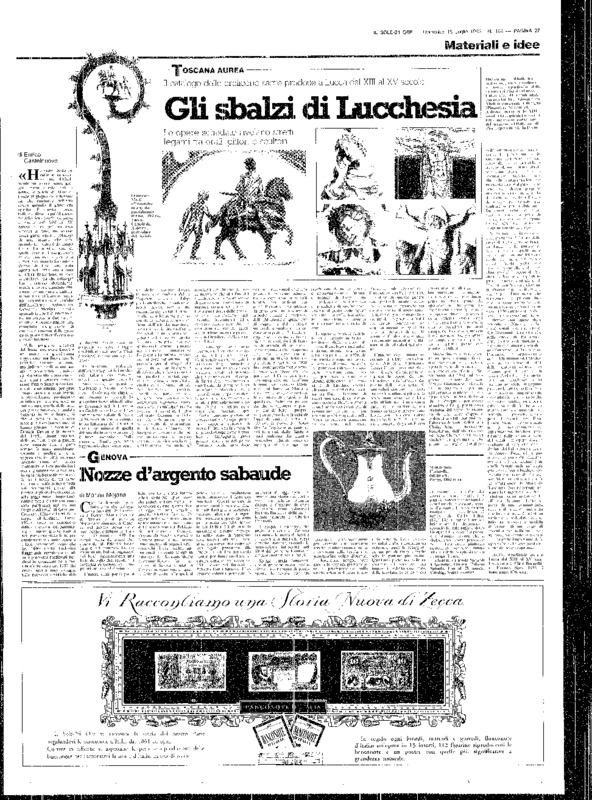
- Titolo
- Gli sbalzi di lucchesia
- Descrizione
- Recensione dell’opera: Oreficeria sacra a Lucca dal XIII al XV secolo, a c. di Clara Baracchini, Firenze, SPES, 1993, 2 voll.; trattasi del catalogo della mostra, tenutasi al Museo nazionale di Palazzo Mansi a Lucca, 19 gennaio-30 settembre 1990. A partire dalla campagna di schedatura delle opere, l’articolo si focalizza sulla ricostruzione del contesto culturale lucchese in cui sono state prodotte: i reciproci scambi tra differenti tecniche artistiche, la circolazione di modelli figurativi tra le città della Toscana, le committenze. Castelnuovo riconosce come fondamentali punti d’avvio degli studi sull’arte lucchese la Mostra d’Arte Sacra. Dal VI al XIX secolo (Lucca, Palazzo Ducale: giugno - settembre 1957) e le ricerche di Carlo Ludovico Ragghianti (Arte a Lucca. Spicilegio, «La Critica d’Arte», VII, 37, 1960, pp. 57-84; riedito in Studi lucchesi, a c. di Gigetta Dalli Regoli, s.l., Rugani edizioni d'arte, 1990).
Al patrimonio culturale lucchese Castelnuovo aveva già dedicato un articolo, incentrato sulla produzione tessile: A Lucca, capitale della seta, «La Stampa», 6 luglio 1989, p. 3 (recensione della mostra: La seta. Tesori di un’antica arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII secolo (Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi: 16 giugno-30 settembre 1989), a c. di Donata Devoti, catalogo edito da Maria Pacini Fazzi).
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. - Autore
- Enrico Castelnuovo
- Fonte
- Il Sole 24 Ore, anno 129, n. 194, p. 27 (inserto Domenica)
- Editore
- Il Sole 24 Ore; digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino (2023)
- Data
- 1993-07-18
- Gestione dei diritti

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale- Relazione
- Inventario del fondo Enrico Castelnuovo, unità archivistica «Il Sole 24 Ore» (Archivio storico dell'Università di Torino)
- Formato
- application/pdf
- Identificatore
- Sole_8
Collezione
Etichette
Citazione
Enrico Castelnuovo, “Gli sbalzi di lucchesia,” Enrico Castelnuovo sulla carta stampata, ultimo accesso il 05 giugno 2025, https://asut.unito.it/castelnuovo/items/show/9.