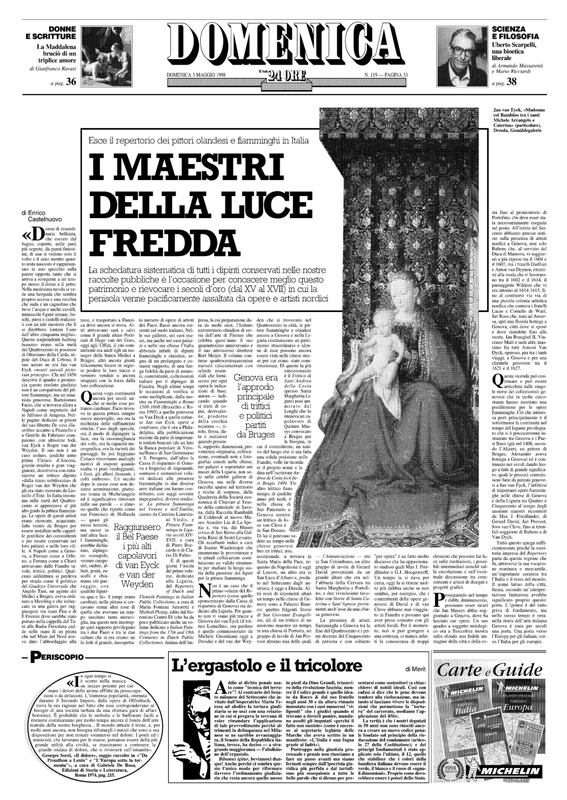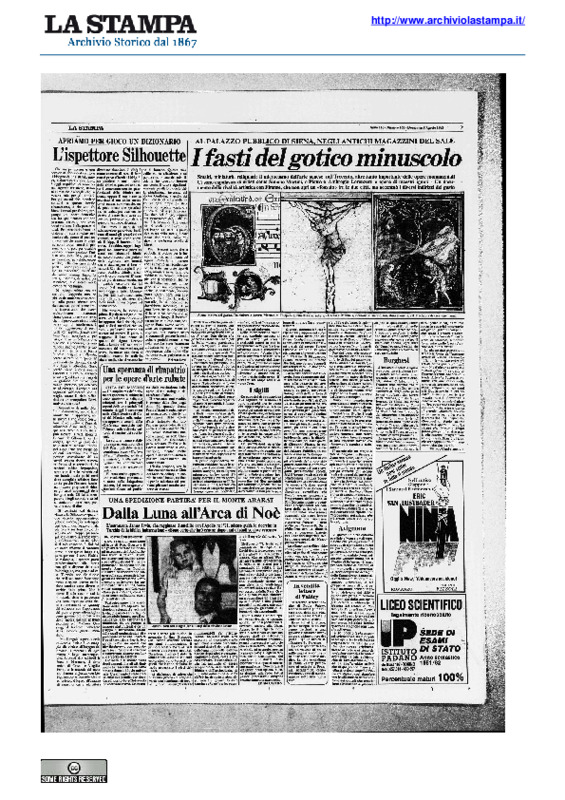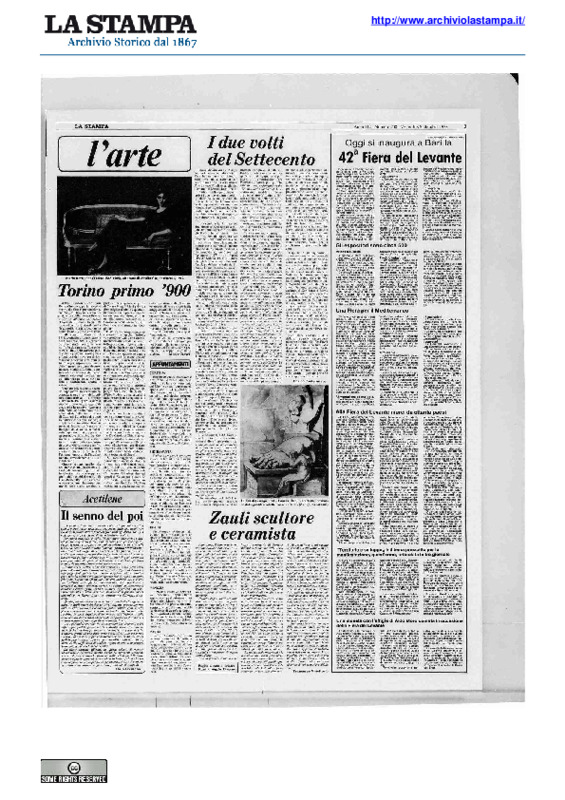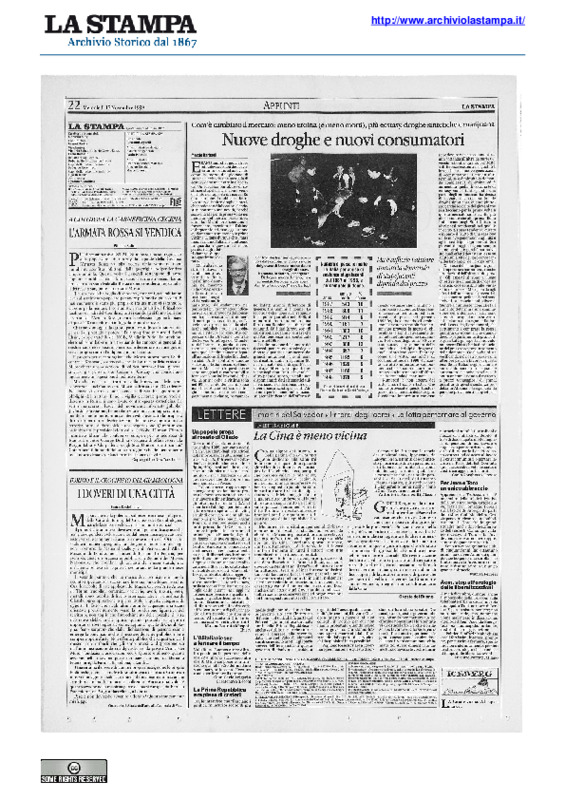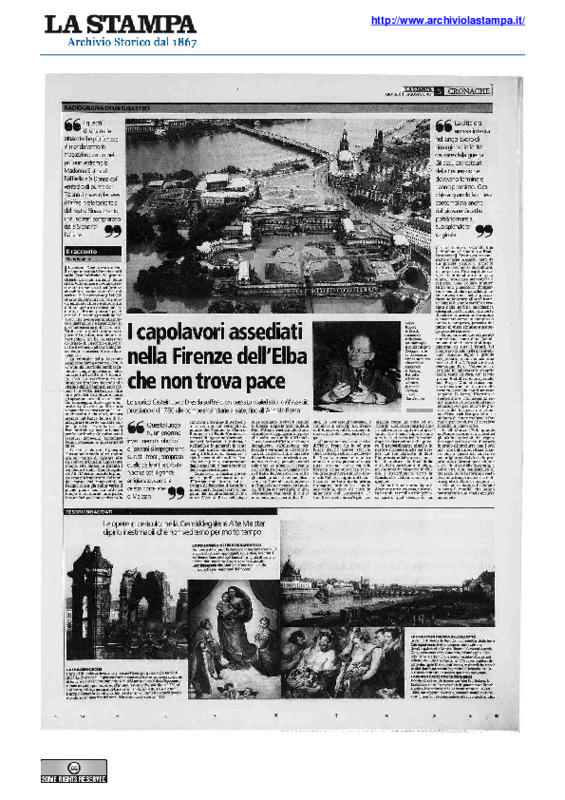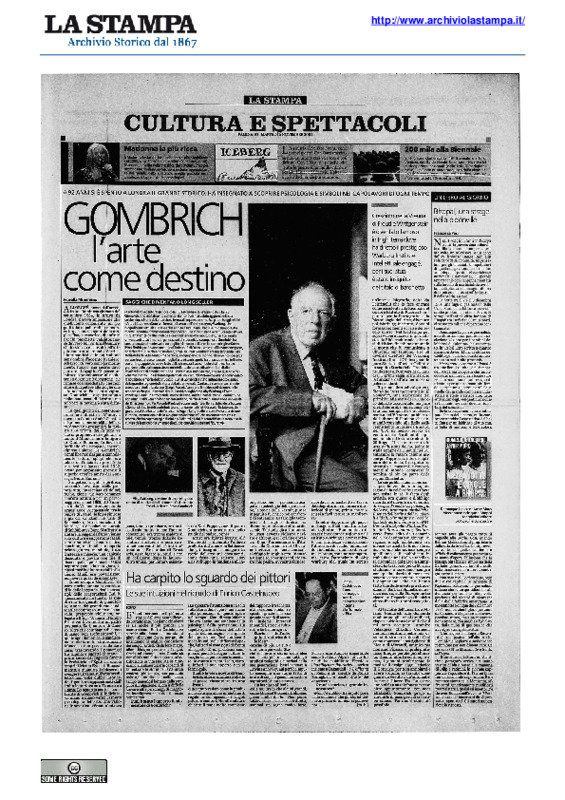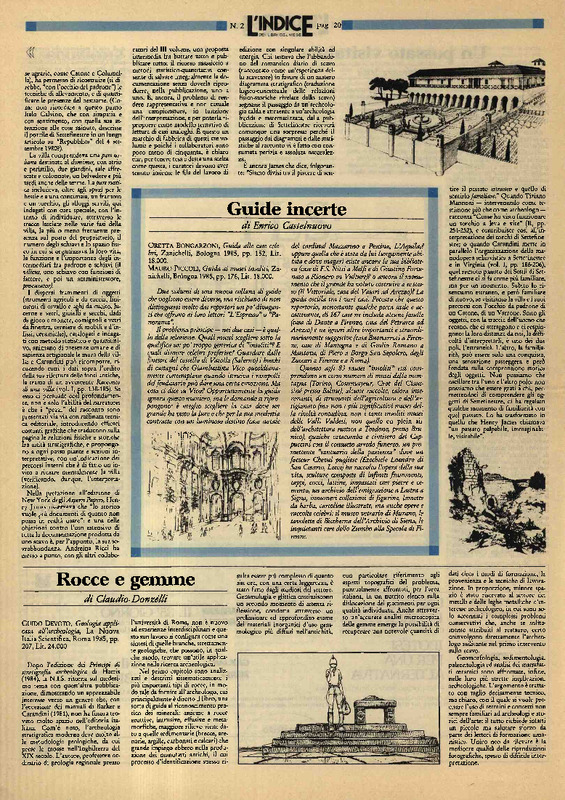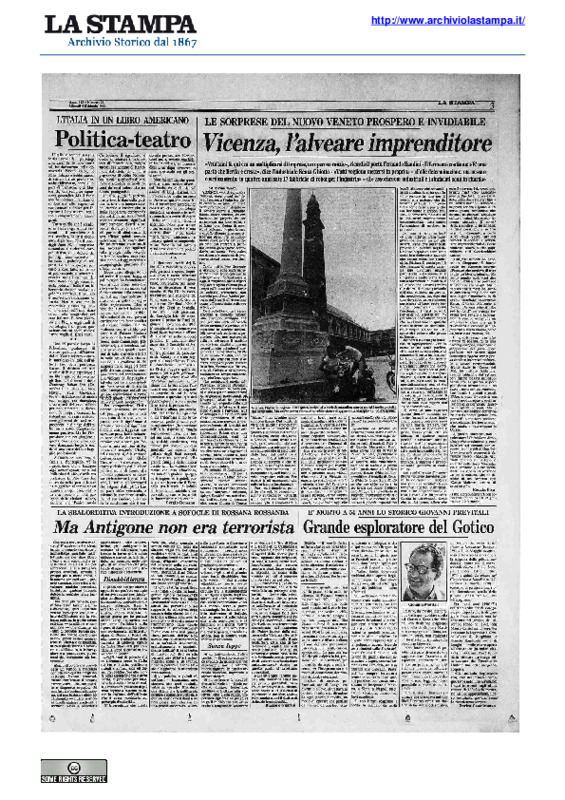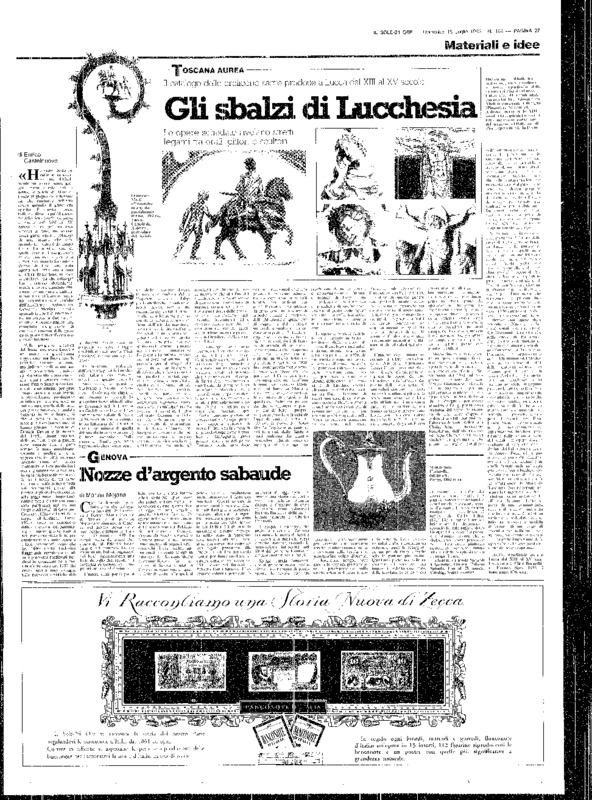Sfoglia documenti (197 in totale)
-
I maestri della luce fredda
Castelnuovo introduce il tema del collezionismo dell’arte olandese e fiamminga in Italia tra XV e XVI secolo, in occasione dell’uscita del primo volume del Repertory of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections, dedicato alla Liguria (a c. di Maria Fontana Amoretti e Michiel Plomp, edito dal Centro Di, 1998; segue la pubblicazione dei volumi sulla Lombardia (2001) e sul Piemonte e Valle d’Aosta (2011). L’articolo si focalizza sulla nascita del gusto per la pittura del nord a partire da alcuni dei protagonisti di questa stagione e sul ruolo giocato da Genova, presentata come la porta degli scambi artistici e culturali tra Olanda e Italia.
Nell’articolo sono richiamate alcune recenti mostre e pubblicazioni sul tema:
- Fiamminghi a Roma, 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 24 febbraio-21 maggio 1995; Roma, Palazzo delle Esposizioni, 16 giugno-10 settembre 1995), catalogo Skira;
- Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo (Genova, Palazzo Ducale, 22 marzo-13 luglio 1997), a c. di Susan J. Barnes, Piero Boccardo, Clario di Fabio e Laura Tagliaferro, catalogo Electa;
- Jan van Eyck: opere a confronto (Torino, Galleria Sabauda, 2 ottobre-14 dicembre 1997), catalogo Umberto Allemandi; Recognizing Van Eyck (Londra, National Gallery, 14 gennaio-15 marzo 1998; Philadelphia, Philadelphia Museum of art, 1° aprile-14 giugno 1998), catalogo edito dal museo: Jan van Eyck: Two Paintings of Saint Francis Receiving the Stigmata;
- La pittura fiamminga nel Veneto e nell'Emilia, a c. di Caterina Limentani Virdis, Verona, Banca popolare di Verona, Banco S. Geminiano e S. Prospero, 1997;
- Pittura fiamminga in Liguria. Secoli XIV-XVII, a c. di Piero Boccardo e Clario Di Fabio, Genova, Banca Carige, Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, 1997.
-
I fasti del gotico minuscolo
Recensione della mostra: Il gotico a Siena. Miniature, pitture, orificerie, oggetti d’arte (Siena, Palazzo Pubblico, 24 luglio-30 ottobre 1982), a c. di Giovanni Previtali, catalogo edito da Centro Di. Ripercorrendo le principali opere, l’intervento traccia un itinerario nell’arte gotica a Siena dalla fine del XIII secolo all’inizio del XV secolo: i nuovi elementi stilistici giunti da Oltralpe accolti e rielaborati in città, dove speciale era la predilezione per le microtecniche; la fortuna degli artisti senesi a Firenze e ad Avignone, divenuti poi modello per l’intera Europa; l’adesione senese al Gotico internazionale e il progressivo spegnersi di ogni innovazione, giunti ormai alle porte del Quattrocento. In particolare, Castelnuovo apprezza la scelta di mettere in rassegna opere di piccolo formato e di differenti tecniche, che ben illustrano come la pittura e la scultura non fossero al vertice della gerarchia delle arti nel periodo in esame.
Per la tematica affine, nella recensione è ricordata la mostra Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V (Parigi, Galeries nationales du Grand Palais: 9 ottobre 1981-1° febbraio 1982), di cui Castelnuovo aveva scritto su «La Stampa». L’anno seguente, una seconda edizione dell’esposizione sull’arte senese è inaugurata ad Avignone: L'art Gothique Siennois. Enluminure, peinture, orfevrerie, sculpture (Avignone, Musée du Petit Palais: 26 giugno-2 ottobre 1983); anche questa è recensita da Castelnuovo su «La Stampa».
Una copia del catalogo è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
I due volti del Settecento
Recensione delle mostre:- Jean-Etienne Liotard, Genf 1702-1789. Sammlung des Musée d'art et d'histoire, Genf (Zurigo, Kunsthaus: 16 giugno-24 settembre 1978, a c. di Renée Loche);
- Johann Heinrich Füssli. 1741-1825 (Ginevra, Musée Rath: 17 giugno-1° ottobre 1978, a c. di Dagmar Hníková).
Una copia di entrambi i cataloghi è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf” (Liotard - Füssli ). -
I doveri di una città
Castelnuovo risponde alle critiche mosse al Comune di Torino per l’acquisto dalla società Antichi maestri pittori, al prezzo di 4.200.000.000 lire, di un crocefisso attribuito a Jean de Boulogne (oggi dato ad Antonio Susini su disegno di Giambologna), da destinarsi al Museo di Arte Antica di Torino (delibera dalla Giunta comunale 99 09945/26, non portata a risoluzione). Castelnuovo, con Giovanni Romano, Enrico Filippi ed Enrica Pagella, era parte del comitato scientifico del Museo di Arte Antica, preposto a valutare gli acquisti per le civiche collezioni; allo stesso tempo, con Romano, aveva più volte collaborato con il proprietario della galleria, Giancarlo Gallino (di Romano è la prefazione al catalogo che presenta il crocefisso: Herbert Keutner, Firenze 1592. Un nuovo crocifisso in argento del Giambologna, Torino, Allemandi, 1999). A oggi non sono note le ulteriori vicende dell’opera. -
I capolavori assediati nella Firenze dell'Elba che non trova pace
Mario Baudino intervista Enrico Castelnuovo in occasione dell’alluvione dell’Elba, focalizzando il dialogo sulle catastrofi che hanno colpito il patrimonio artistico di Dresda dal XVIII secolo sino a oggi. -
Hüttinger «modu par la peinture»
Necrologio di Eduard Hüttinger (Winterthur [Svizzera], 6 gennaio 1926-Zurigo [Svizzera], 14 agosto 1998). Sin dal titolo, Castelnuovo presenta Hüttinger come “mordue par la peinture”, introducendo i suoi studi sulla pittura veneziana e olandese, la sua collezione d’arte e il suo rapporto profondo con l’Italia. In particolare, commenta l’insegnamento in Svizzera e Germania, l’impegno di divulgatore sulla «Neue Zürcher Zeitung» e alcune pubblicazioni:- Case d'artista. Dal Rinascimento a oggi (Bollati Boringhieri, 1992), già presentato su «La Stampa» nel 1992;
- Portrats und Profile. Zur Geschichte der Kunstgeschichte (Erker Verlag, 1992)
- due articoli pubblicati su «Paragone», Immagini e interpretazioni della Venezia dell’Ottocento (XXIII, 271, settembre 1972) e Pluralismo di stili nell’opera di Roberto Longhi (XXVII, 311, gennaio 1976).
-
Ha carpito lo sguardo dei pittori
Mario Baudino intervista Enrico Castelnuovo in occasione della morte di Ernst Gombrich (Vienna, 30 marzo 1909-Londra 3 novembre 2001), focalizzando il dialogo sull’apporto che Gombrich lascia in eredità alla storia dell’arte. Il contributo accompagna l’articolo di Fiorella Minervino, Gombrich, l’arte come destino. Negli stessi giorni, Castelnuovo ricorda lo storico dell'arte anche sul domenicale de «Il Sole 24 Ore» (11 novembre 2002). -
Guide incerte
Recensione delle opere: Oretta Bongarzoni, Guida alle case celebri, Bologna, Zanichelli, 1985; Mauro Piccoli, Guida ai musei insoliti, Bologna, Zanichelli, 1985. Pur riconoscendo alcuni spunti originali, Castelnuovo evidenzia i limiti della selezione operata dalle due guide, a partire dagli stessi titoli, lamentando non solo l’assenza di un’impostazione rigorosa, ma l’inclusione di luoghi di dubbia autenticità a discapito di altri che ritiene di maggior rilievo storico-artistico. -
Grande esploratore del Gotico
Necrologio di Giovanni Previtali (Firenze, 4 marzo 1934-Roma, 3 febbraio 1988). A partire dai ricordi personali, Castelnuovo ne traccia un profilo in cui ricorda il loro primo incontro e gli studi con Roberto Longhi e si sofferma sul suo apporto alla storia dell’arte, segnalando le principali pubblicazioni e le ultime mostre. Delle tre esposizioni citate, aveva già pubblicato una recensione su «La Stampa»:- Il gotico a Siena. Miniature, pitture, orificerie, oggetti d’arte (Siena, 1982) e L'art Gothique Siennois. Enluminure, peinture, orfevrerie, sculpture (Avignone, 1983);
- Simone Martini e “chompagni” (Siena, 1985);
- Scultura dipinta. Maestri di legname e pittori a Siena. 1250-1450 (Siena, 1987).
-
Gli sbalzi di lucchesia
Recensione dell’opera: Oreficeria sacra a Lucca dal XIII al XV secolo, a c. di Clara Baracchini, Firenze, SPES, 1993, 2 voll.; trattasi del catalogo della mostra, tenutasi al Museo nazionale di Palazzo Mansi a Lucca, 19 gennaio-30 settembre 1990. A partire dalla campagna di schedatura delle opere, l’articolo si focalizza sulla ricostruzione del contesto culturale lucchese in cui sono state prodotte: i reciproci scambi tra differenti tecniche artistiche, la circolazione di modelli figurativi tra le città della Toscana, le committenze. Castelnuovo riconosce come fondamentali punti d’avvio degli studi sull’arte lucchese la Mostra d’Arte Sacra. Dal VI al XIX secolo (Lucca, Palazzo Ducale: giugno - settembre 1957) e le ricerche di Carlo Ludovico Ragghianti (Arte a Lucca. Spicilegio, «La Critica d’Arte», VII, 37, 1960, pp. 57-84; riedito in Studi lucchesi, a c. di Gigetta Dalli Regoli, s.l., Rugani edizioni d'arte, 1990).
Al patrimonio culturale lucchese Castelnuovo aveva già dedicato un articolo, incentrato sulla produzione tessile: A Lucca, capitale della seta, «La Stampa», 6 luglio 1989, p. 3 (recensione della mostra: La seta. Tesori di un’antica arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII secolo (Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi: 16 giugno-30 settembre 1989), a c. di Donata Devoti, catalogo edito da Maria Pacini Fazzi).
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”.