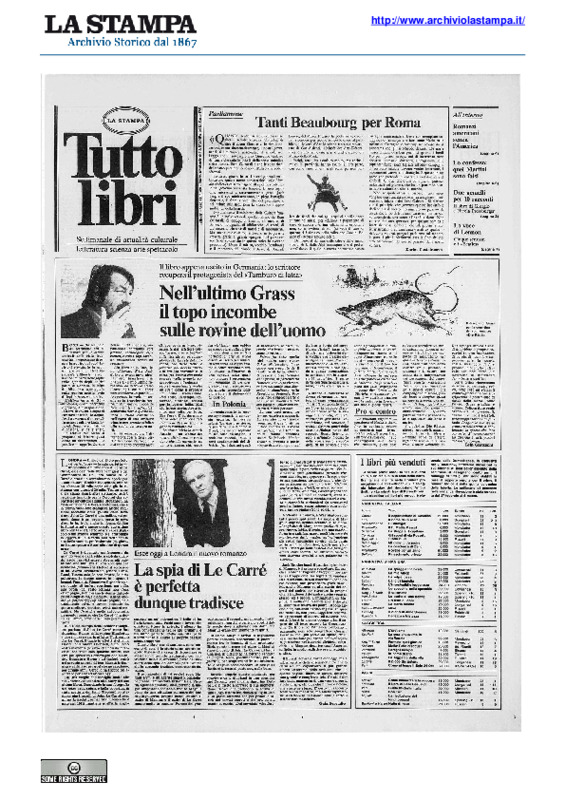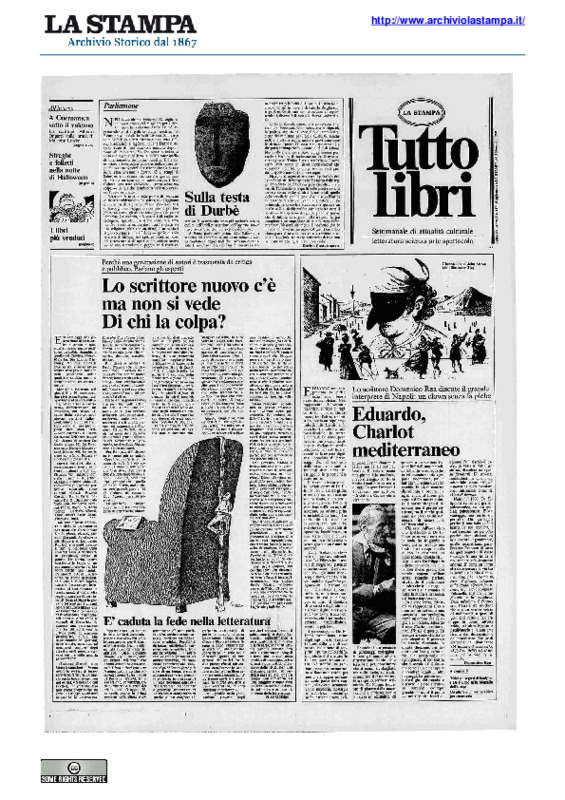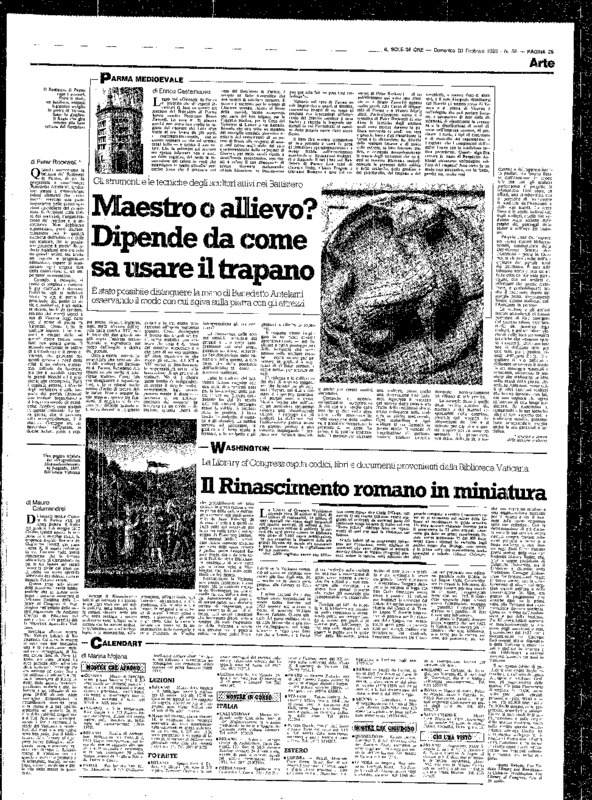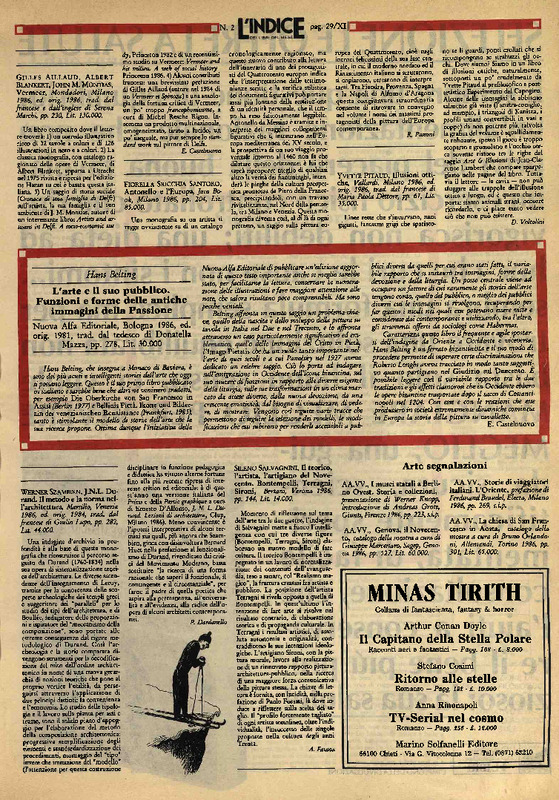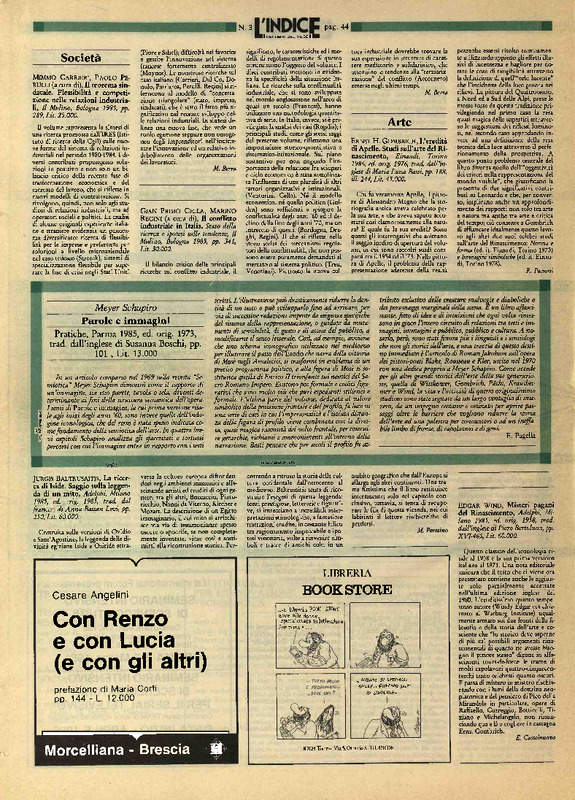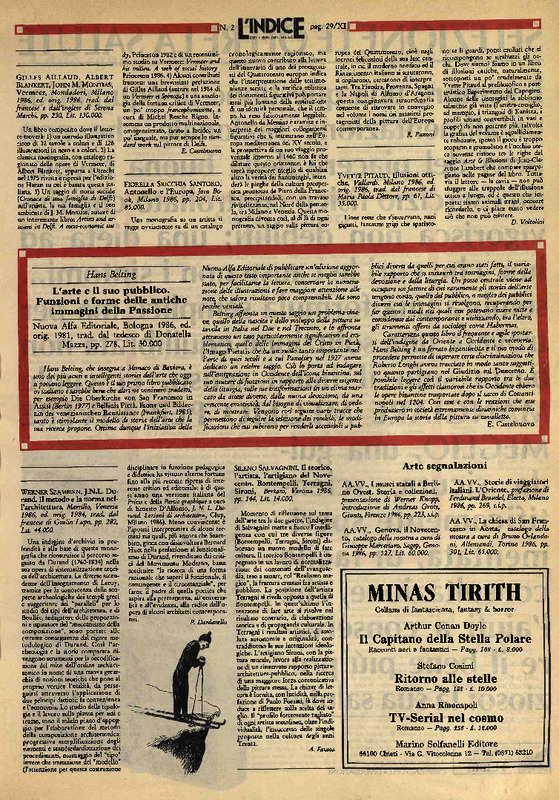Sfoglia documenti (224 in totale)
-
Tiepolo, trecento anni dopo
Castelnuovo interviene sulla fortuna critica di Giambattista Tiepolo (1696-1770) a partire dal giudizio del proprio maestro Roberto Longhi (il richiamo implicito va al Dialogo tra il Caravaggio e il Tiepolo, « Paragone», II (1951), 23, pp. 57-64). L’attuale celebrazione unanime di Tiepolo lo porta a rilevare quanto, nella ricezione della sua opera, sia venuta meno la dialettica che aveva animato il dibattito nel passato, quando lo scontro tra posizioni divergenti aveva generato letture feconde. Nell’articolo sono richiamate due fondamentali esposizioni: la Mostra Tiepolesca (Venezia, Palazzo Reale, maggio 1896) e la Mostra del Tiepolo (Venezia, Giardini della Biennale, 16 giugno-7 ottobre 1951, a cura di G. Lorenzetti).
Nel trecentesimo anniversario della nascita, «L'Indice dei libri del mese» sceglie il pittore come tema del numero di novembre, raccogliendo anche gli interventi Roberta Battaglia, Maria Beltramini e Massimiliano Rossi. -
Tempeste iconoclaste
Recensione della mostra: Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? (Berna, Bernisches Historisches Museum, 2 novembre 2000-16 aprile 2001; Strasburgo, Musée de l'Œuvre Notre-Dame, 12 maggio-26 agosto 2001), a c. di Johannes Tripps. Castelnuovo torna sul tema del valore simbolico e degli usi delle immagini sacre, presentando il fenomeno della rimozione e distruzione delle opere durante i moti iconoclasti della Riforma protestante. L’esposizione nasce, appunto, dal ritrovamento di un gruppo di sculture, sepolte in quel periodo turbolento, negli scavi attorno alla Collegiata si San Vincenzo di Berna, per indagare quale significato e quale potere evocativo queste opere abbiano avuto sugli uomini di quel tempo.
Nell’articolo sono menzionate, vista l’impostazione affine, le mostre Sacre passioni. Scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 8 novembre 2000-8 aprile 2001), recensita da Castelnuovo il 12 novembre, e Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum, 31 maggio-8 ottobre 2000), da lui presentata il 17 settembre. -
Temperamenti difficili
Recensione dell'opera: Bernard Berenson e Roberto Longhi, Lettere e scartafacci, 1912-1957, a c. di Cesare Garboli e Cristina Montagnani, con un saggio di Giacomo Agosti, Milano, Adelphi, 1993.
Un “dossier incalzante”: così Castelnuovo introduce l’edizione della corrispondenza tra i due storici dell’arte. A partire dal progetto incompiuto di tradurre gli scritti di Berenson, queste lettere – insieme ai saggi che le accompagnano – offrono l’occasione per ricostruire un rapporto tumultuoso, nonché l’evoluzione delle loro visioni della storia dell’arte, negli anni sempre più distanti (“Non eravamo temperamenti facili” dichiara lo stesso Longhi, nella prefazione dei propri Scritti giovanili). Parte del carteggio era già stata pubblicata: è ricordato il saggio di Flora Bellini sulla prima lettera di Longhi a Berenson (Una passione giovanile di Roberto Longhi: Bernard Berenson, in L’arte di scrivere sull’arte: Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo, a c. di Giovanni Previtali, Roma, Editori Riuniti, 1982, pp. 9-26). Chiude l’articolo una bibliografia selezionata sui due storici dell’arte, che comprende anche i principali titoli che Berenson e Longhi hanno licenziato negli anni in cui furono in contatto.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla
Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Tanti Beaubourg per Roma
Pamphlet polemico contro l'esiguità dei fondi statali destinati al settore dei beni culturali, a partire dalle dichiarazioni del sottosegretario del Ministero dei Beni culturali e ambientali Giuseppe Galasso. Nella seduta del 2 ottobre 1985 della VIII Commissione permanente (Istruzione) della Camera dei Deputati era emerso che la previsione di spesa per i beni culturali sarebbe stata limitata allo 0,22% del bilancio dello Stato. Lo stesso giorno in cui «La Stampa» pubblicava le dichiarazioni di Galasso, il 13 marzo 1986 (p. 2), «Le Monde» dedicava quattro pagine ai progetti promossi oltralpe dal ministro della Cultura Jack Lang, giunto a fine mandato (1981-86; pp. 17-20). Castelnuovo li richiama, guardando con ammirazione alla politica culturale della Francia: in particolare sottolinea come i grandi investimenti messi in campo abbiano permesso di rinnovare numerose istituzioni culturali e di inaugurare importanti musei, a cui il titolo dell'articolo allude. -
Sulla testa di Durbè
Pamphlet polemico sulla direzione del Ministero dei beni culturali e ambientali: Castelnuovo accusa il Consiglio d’amministrazione per la mancanza di trasparenza e l’arbitrarietà nella gestione degli spostamenti di sede dei soprintendenti, che spesso non considerano i legami col territorio e i progetti in corso (è portato ad esempio il trasferimento di Liliana Mercando dal Museo Archeologico di Torino, in corso di riallestimento). L’intervento prende le mosse dalla destituzione di Dario Durbè dalla carica di soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, a seguito dello scandalo dei falsi Modigliani di Livorno, ricordando all’opposto il caso del direttore generale Guglielmo Triches, coinvolto in scandali valutari ma non rimosso dall’incarico al Ministero.
Segue una lettera di risposta invita al quotidiano dall'ex-direttore della Rai di Torino Giovanni Viarengo, fortemente critica contro l’operato di Durbé, e un secondo intervento di Castelnuovo, che meglio puntualizza le sue posizioni.
L’articolo è richiamato nel question time della seduta pomeridiana del Senato del 14 novembre 1984, nell’interrogazione avanzata da Olindo Del Donno al ministro dei Beni culturali e ambientali. -
Sul restauro del Battistero di Parma di Bruno Zanardi
Castelnuovo commenta il restauro degli apparati scultorei di Benedetto Antelami del Battistero di Parma, diretto da Bruno Zanardi tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta. L’articolo si inserisce nel dibattito sulla pulitura delle superfici lapidee, infiammatosi nel corso del 1992 a causa della rimozione della patina nera che le ricopriva, con polemiche così aspre da portare all’interruzione del cantiere. Richiamando il parere favorevole sull’intervento rilasciato dalla commissione di esperti incaricati dal Ministero («Il Giornale dell’Arte», n. 108, febbraio 1993, p. 2), Castelnuovo difende i risultati del restauro, accodandosi a quando già espresso da Giorgio Bonsanti e Giuliano Briganti (Al mondo dei restauri sono saltati i nervi, «Il Giornale dell’Arte», n. 97, febbraio 1992, p. 58; Perché sparate sul Battistero, «La Repubblica», 12 settembre 1992, p. 35).
Accompagna l’articolo un contributo di Peter Rockwell, Maestro o allievo? Dipende da come sa usare il trapano, dedicato all’identificazione degli artisti attivi nel Battistero tramite l’analisi della tecnica e gli strumenti da loro impiegati (tratto dalla pubblicazione edita in occasione del restauro: La decorazione plastica. Le tecniche d’intaglio, in Battistero di Parma, Parma-Milano, Cassa di Risparmio di Parma-F.M. Ricci, 1992, vol. I - l’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”). -
Su Lo schiavo del manoscritto di Amitav Ghosh
Recensione dell'opera: Amitav Ghosh, Lo schiavo del manoscritto, a c. di Anna Nadotti, Torino, Einaudi, 1993. -
Su Vermeer di Gilles Aillaud, Albert Blankert, John Michael Montias
Recensione dell'opera: Gilles Aillaud, Albert Blankert, John Michael Montias, Vermeer, Milano, Mondadori (Pagine d'arte), 1986 (traduzione di Serena Marchi; I. ed. Hazan, 1986). Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Su Misteri pagani del Rinascimento di Edgar Wind
Recensione dell'opera: Edgar Wind, Misteri pagani nel Rinascimento, Milano, Adelphi, 1985 (traduzione di Piero Bertolucci). Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”.
Nello stesso numero de «L’Indice dei libri del mese» Castelnuovo presenta in un ampio articolo L'inchiostro variopinto di Federico Zeri. -
Su L’arte e il suo pubblico di Hans Belting
Recensione dell'opera: Hans Belting, L'arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche immagini della passione, Bologna, Nuova Alfa (Rapporti, 56), 1986 (introduzione di Giorgio Cusatelli, traduzione di Donatella Mazza; I ed. Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Berlino, Mann, 1981). Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”.