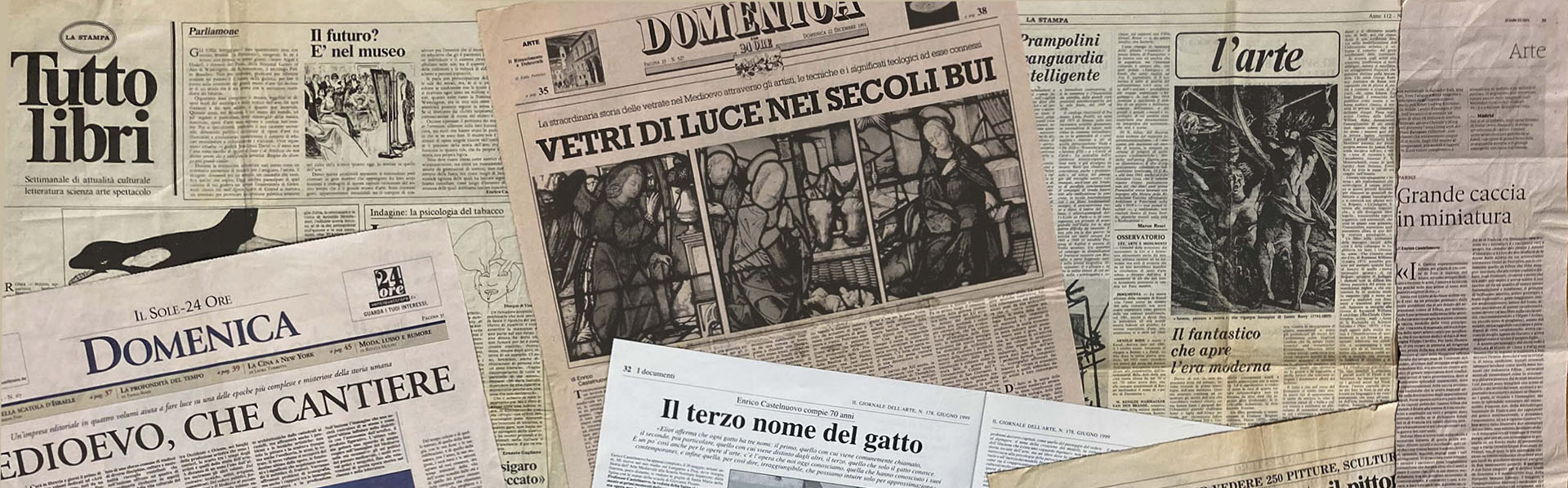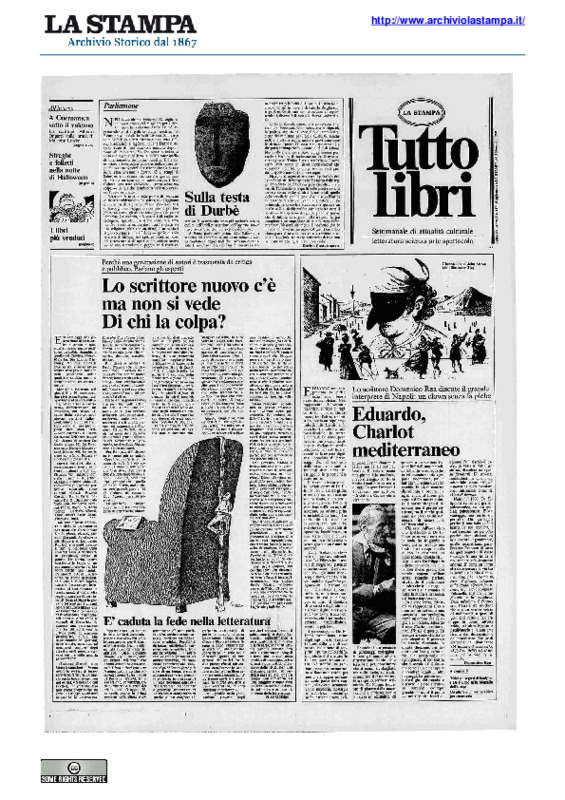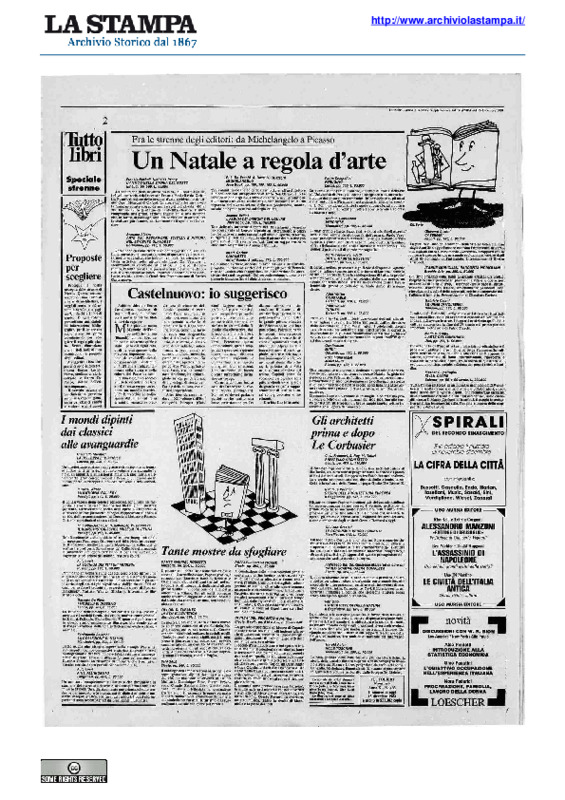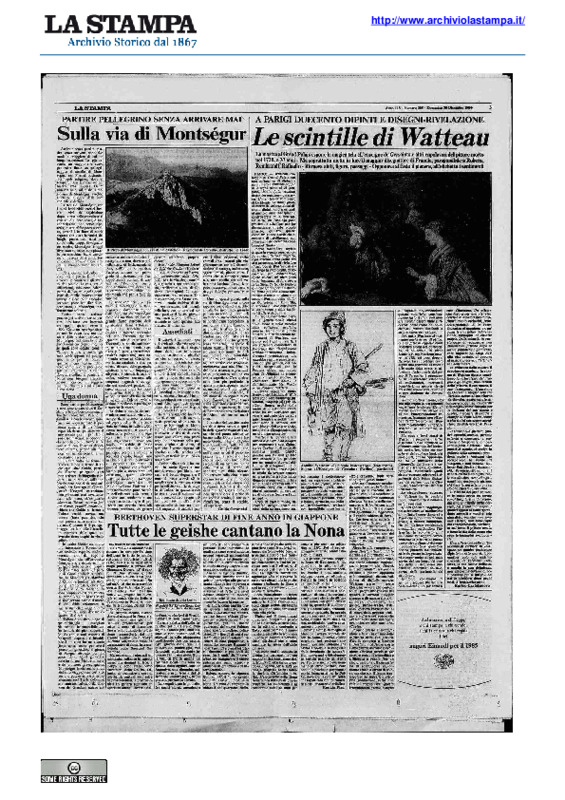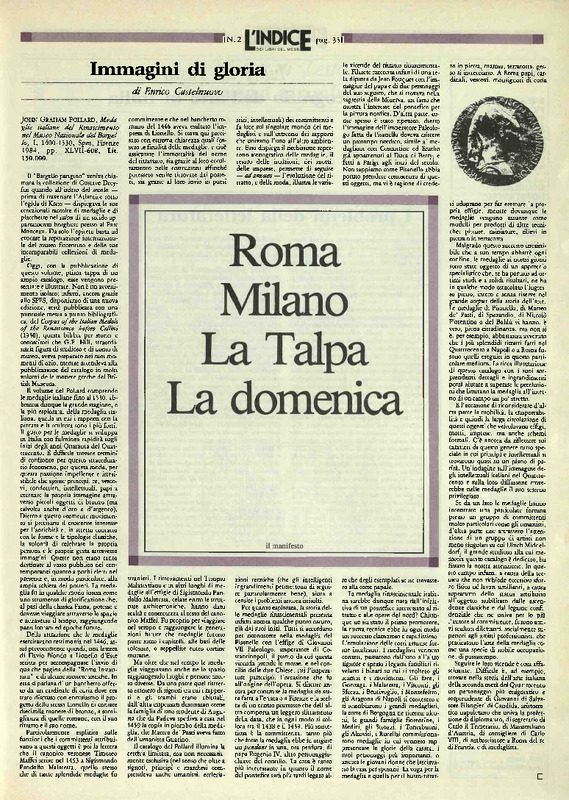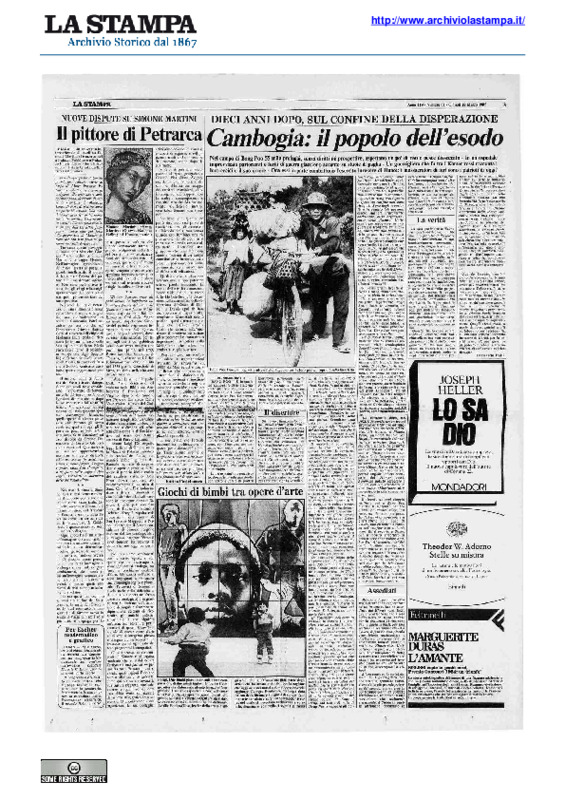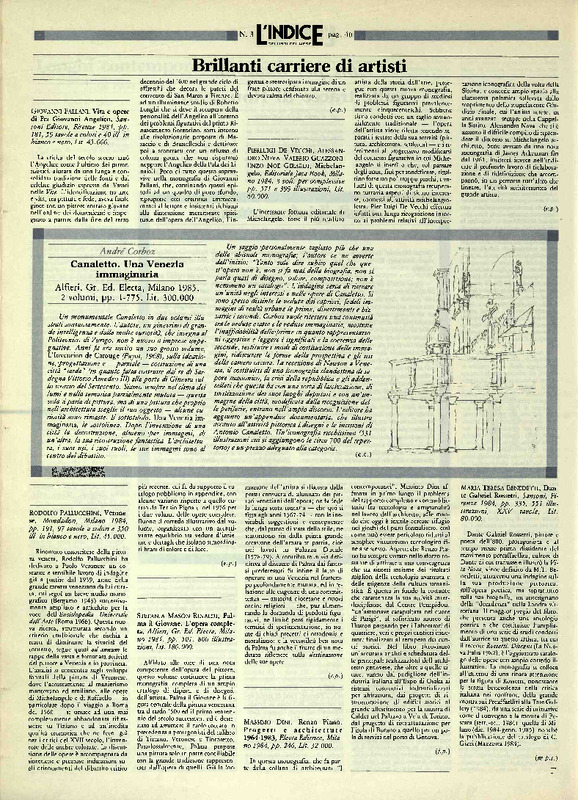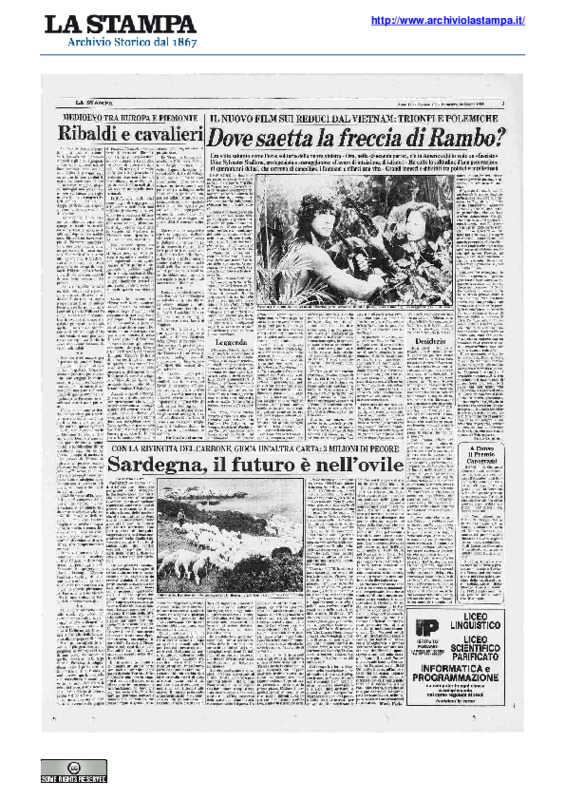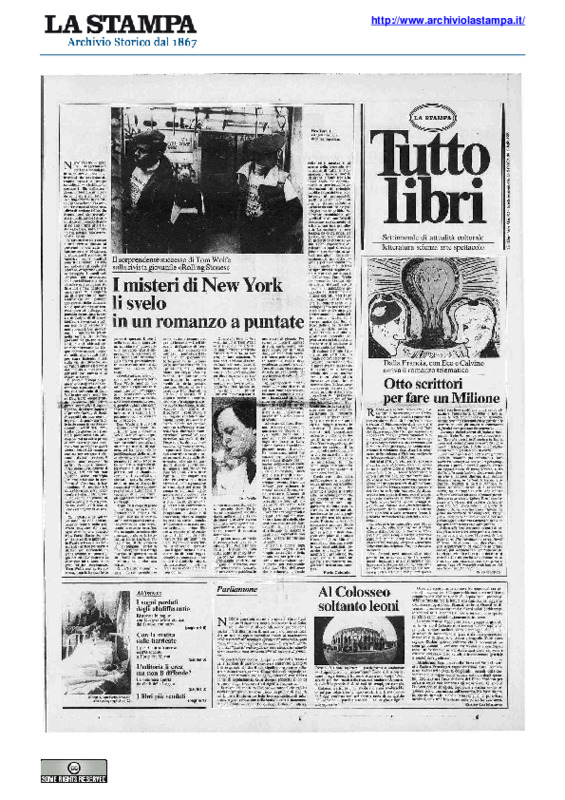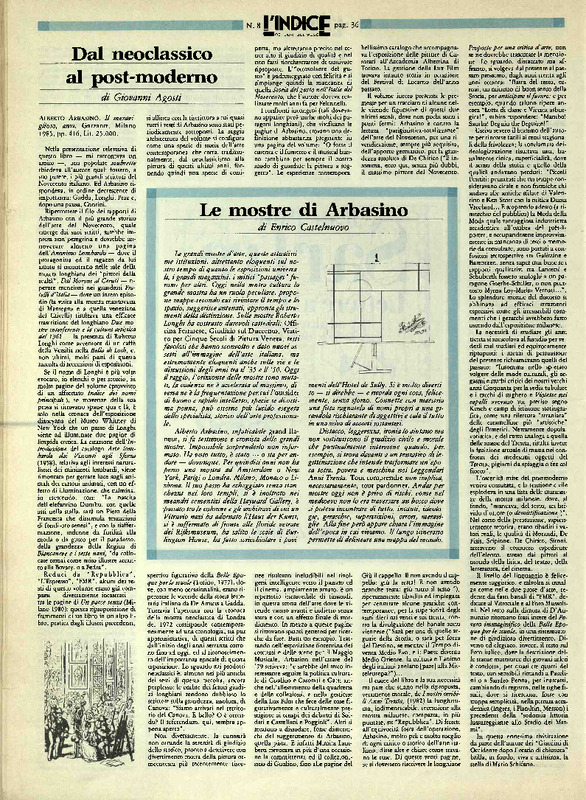Sfoglia documenti (179 in totale)
Ordina per
-
Sulla testa di Durbè
Pamphlet polemico sulla direzione del Ministero dei beni culturali e ambientali: Castelnuovo accusa il Consiglio d’amministrazione per la mancanza di trasparenza e l’arbitrarietà nella gestione degli spostamenti di sede dei soprintendenti, che spesso non considerano i legami col territorio e i progetti in corso (è portato ad esempio il trasferimento di Liliana Mercando dal Museo Archeologico di Torino, in corso di riallestimento). L’intervento prende le mosse dalla destituzione di Dario Durbè dalla carica di soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, a seguito dello scandalo dei falsi Modigliani di Livorno, ricordando all’opposto il caso del direttore generale Guglielmo Triches, coinvolto in scandali valutari ma non rimosso dall’incarico al Ministero.
Segue una lettera di risposta invita al quotidiano dall'ex-direttore della Rai di Torino Giovanni Viarengo, fortemente critica contro l’operato di Durbé, e un secondo intervento di Castelnuovo, che meglio puntualizza le sue posizioni.
L’articolo è richiamato nel question time della seduta pomeridiana del Senato del 14 novembre 1984, nell’interrogazione avanzata da Olindo Del Donno al ministro dei Beni culturali e ambientali. -
La verità dei pittori
Castelnuovo sottolinea come il contesto in cui gli artisti vivono li ispiri e influenzi i loro “schemi rappresentativi”: per illustrare questa tesi, sono portate ad esempio le illustrazioni del Paradiso perduto di John Martin (1789-1854), dove il tunnel di Londra sotto il Tamigi diventa il modello per le tenebrose caverne, e le scene bibliche del pittore olandese Frans Post (1612-1680), in cui la flora e la fauna si presenta affine a quella copiata durante la spedizione in Brasile promossa da Maurizio di Nassau. Questo caso introduce la seconda questione toccata nell’articolo, la pittura come strumento per conoscere il mondo e registrare la “realtà” nell’Olanda del XVII secolo.
Sono citati un convegno tenutosi a Rotterdam (Arte, tecnica e società, da identificare), in cui Castelnuovo era intervenuto su Martin e il rapporto tra arte e rivoluzione industriale e la monografia di Svetana Alpers, Arte del descrivere. Scienza e pittura nel Seicento olandese, di cui aveva curato la prefazione (Bollati Boringhieri, 1984; I ed. The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, 1983). Una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Castelnuovo: io suggerisco
Consigli di lettura per le prossime festività natalizie: nel trafiletto, parte di una pagina dedicata alle strenne natalizie, sono presentati- L'uso dei classici, parte di Memoria dell'antico nell'arte italiana, a c. di Salvatore Settis, Torino, Einaudi, vol. I;
- Bibliografia, repertorio, statistiche, parte dell'Enciclopedia Europea, Milano, Garzanti, vol. XII;
- Svetlana Alpers, Arte del descrivere. Scienza e pittura nel Seicento olandese, Torino, Bollati Boringhieri.
Insieme a Luciano Berti, Pierluigi De Vecchi e Mauro Natale, Castelnuovo aveva elaborato il piano editoriale della sezione storico-artistica dell’Enciclopedia europea, edita da Garzanti tra 1976 e 1984. Del volume di Alpers, aveva scritto la prefazione all’edizione italiana: una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. Tutte le opere menzionate nell’articolo sono edite nel 1984.
-
Le scintille di Watteau
Recensione della mostra: Watteau 1684-1721 (Washington, National gallery of art: 17 giugno-23 settembre 1984; Parigi, Galeries nationales du Grand Palais: 23 ottobre 1984-28 gennaio 1985; Berlino, Castello di Charlottenburg: 22 febbraio-26 maggio 1985), a c. di Pierre Rosenberg. Presentando la tappa parigina dell’esposizione, Castelnuovo segnala quanto siano discordanti i giudizi sui disegni e sulla pittura di Watteau: se l’apprezzamento per la grafica è pressoché incondizionato, parecchie sono invece le riserve verso l’opera pittorica, in particolare sulle tele meno conosciute portate in mostra da Rosenberg. Già i conoscitori che avevano conosciuto il maestro segnalano la sua predilezione per il disegno, di contro a un’insoddisfazione verso la propria pittura; il cattivo stato di conservazione della pellicola pittorica di molte opere, dovuto alla stessa tecnica adoperata e ai successivi restauri, fa sì che oggi siano generalmente meno apprezzate. Per meglio comprendere il pittore, Castelnuovo rimarca la necessità di nuovi studi attenti al teatro e alla letteratura dell’epoca, per meglio comprendere i soggetti abitualmente rappresentati, e alla storia del gusto e del costume della società francese dell’epoca, che tanto invece lo aveva apprezzato.
Una copia del catalogo è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Immagini di gloria
Recensione del primo volume di Medaglie italiane del Rinascimento nel Museo nazionale del Bargello, a c. di John Graham Pollard: 1400-1530, Firenze, Associazione amici del Bargello-SPES, 1984. Nel presentare l’opera, Castelnuovo si sofferma sull’interesse, divenuto vera e propria moda, per le medaglie nella cultura del Quattrocento, introducendo i significati eruditi e simbolici del fenomeno, il loro posizionamento nel sistema delle arti del Rinascimento e alcuni tra gli artisti, gli umanisti e i committenti più coinvolti.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Il pittore di Petrarca
Intervento sul ruolo sociale dell'artista incentrato sul rapporto tra Martini e Petrarca, in occasione della mostra Simone Martini e “chompagni” (Siena, Pinacoteca Nazionale, 27 marzo-31 ottobre 1985) e del convegno Simone Martini (Siena, Palazzo Pubblico e Palazzo Patrizi: 27-29 marzo 1985); gli atti sono editi da Centro Di nel 1988, a c. di Luciano Bellosi. L’articolo ripercorre la letteratura artistica da Ghiberti a Vasari, constatando come la figura del poeta abbia oscurato il lavoro del pittore almeno sino alla fine del XVIII secolo. La conoscenza di nuove opere, entrate nelle collezioni pubbliche e private a seguito della soppressione degli enti ecclesiastici, ha favorito l’avvio di nuovi studi su Martini che hanno progressivamente rimesso a fuoco il contesto storico-sociale in cui operava e, in ultimo, ricomposto il suo catalogo.
Questi temi sono trattati da Castelnuovo nell’intervento di apertura del convegno, dove accenna al dibattito in corso sull’attribuzione a Martini del Guidoriccio da Fogliano (avvalora il giudizio di Max Seidel e Luciano Bellosi, che riconoscono Martini come autore dell’affresco: “Castrum pingatur in palatio” 1 e 2, «Prospettiva»: 28, gennaio 1982; Gordon Moran, An Investigation Regarding the Equestrian Portrait of Guidoriccio da Fogliano in the Siena Palazzo Pubblico, «Paragone», 333, novembre 1977; sulla polemica cfr. Giovanna Ragionieri, Simone o non Simone, Firenze, Ponte alle Grazie, 1985).
Il contributo pubblicato come Introduzione degli atti del convegno è una versione più estesa di questo articolo, che approfondisce le vicende attributive-collezionistiche delle opere di Martini e il suo apporto al genere del ritratto. Il saggio è riedito col titolo Fortuna e sfortuna di Simone nella raccolta La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000). -
Su Canaletto di André Corboz
Recensione dell'opera: André Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria, Venezia-Milano, Alfieri-Electa, 1985, 2 voll. Questo studio, superando il taglio biografico, appassiona Castelnuovo perché indaga la Venezia immaginaria costruita da Canaletto, tra realtà e invenzione, alla ricerca delle modalità operative e delle iconografie predilette dal pittore, dei significati simbolici e delle implicazioni culturali espressi con continuità nelle vedute e nei capricci.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Ribaldi e cavalieri
Intervento sul Piemonte nel medioevo, in occasione della pubblicazione della Festschrift dedicata a Giovanni Tabacco per i suoi settant’anni (Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino, Einaudi, 1985) e del trentaquattresimo Congresso storico subalpino (Dal Piemonte all’Europa. Esperienze monastiche nelle società medievali, Torino: 27-29 maggio 1985); gli atti sono editi dalla Deputazione subalpina di storia patria nel 1988. A partire dalla tradizionale interpretazione del Piemonte come terra di confine, quindi marginale sino alla rifondazione dello stato moderno di Emanuele Filiberto, Castelnuovo presenta la frontiera come luogo privilegiato di scambio e confronto culturale. Sulla scia degli studi di Giovanni Tabacco e degli interventi del convegno, porta ad esempio gli avventurosi viaggi dei pellegrini, che da Oltralpe raggiungevano le abbazie piemontesi, ed altri episodi che inquadrano chiaramente la regione nello scacchiere internazionale del XIII-XIV secolo.
Una copia degli atti del convegno è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Al Colosseo soltanto leoni
Castelnuovo si interroga sull’utilizzo dei siti storici e archeologici per fini culturali, sollecitato dalla sentenza del pretore di Roma, Alberto Albamonte, del 10 luglio 1985. Nelle motivazioni non solo era precisato che i beni culturali dovessero essere destinati a finalità che non ne pregiudicassero la conservazione e l’integrità, ma era soprattutto sottolineato che non potessero essere concessi per scopi non pertinenti alla loro identità originaria. Diversa è la posizione di Castelnuovo, secondo cui l’attenzione è da rivolgere alla preservazione dei beni culturali e non tanto al loro carattere originario, in quanto non è raro che nel tempo abbiano cambiato più volte destinazione d’uso. Il caso della concessione della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per spettacoli teatrali, citato nell’articolo, è richiamato non tanto per i contenuti ma per i rischi che l’affollamento comporta all’edificio.
Castelnuovo prende le mosse dalla pagina che «L’Unità» dedica alla questione l’11 luglio 1985 (p. 17): il soprintendente ai Beni archeologici di Roma, Adriano La Regina, era stato accusato di abuso di potere e omissione di atti d'ufficio per avere autorizzato una rassegna cinematografica al Circo Massimo e una mostra sull’economia italiana nel Ventennio al Colosseo. Nonostante l’assoluzione, nelle motivazioni del pronunciamento il pretore – poggiando sul parere di una commissione composta da Lorenzo Quilici, Italo Insolera, Vincenzo Cabianca e Giulio Tamburini – criticava apertamente la concessione dei due siti archeologici, ritenendo le manifestazioni non compatibili con “il carattere espressivo del monumento, quale testimonianza storica e quale valore culturale [...]”. -
Le mostre di Arbasino
Recensione dell'opera: Alberto Arbasino, Il meraviglioso, anzi, Milano, Garzanti, 1985; nella stessa pagina il volume è anche recensito da Giovanni Agosti: Dal neoclassicismo al post-moderno. Castelnuovo riconosce in Alberto Arbasino un osservatore brillante e onnivoro, capace di coniugare nei suoi articoli sulle esposizioni d’arte, ora raccolti in questo volume, leggerezza stilistica e profondità critica. A ben guardare non sempre una recensione è un pezzo di servizio: prendendo le mosse da una mostra, alcuni degli scritti più noti di Roberto Longhi, richiamati nell’articolo, hanno infatti ridefinito diversi capitoli dell’arte italiana.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”.