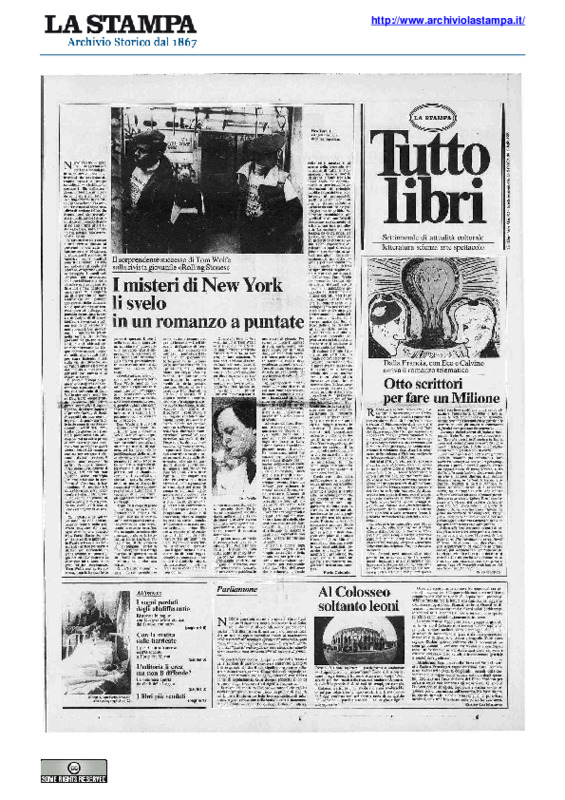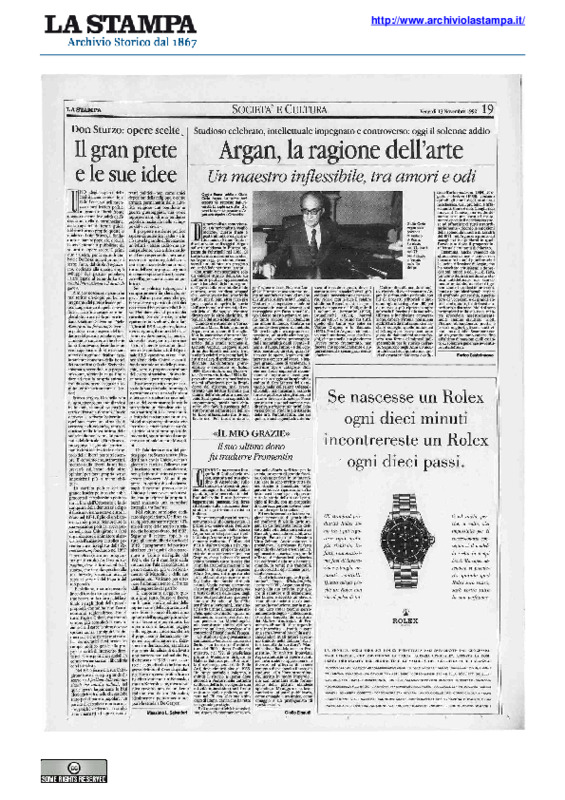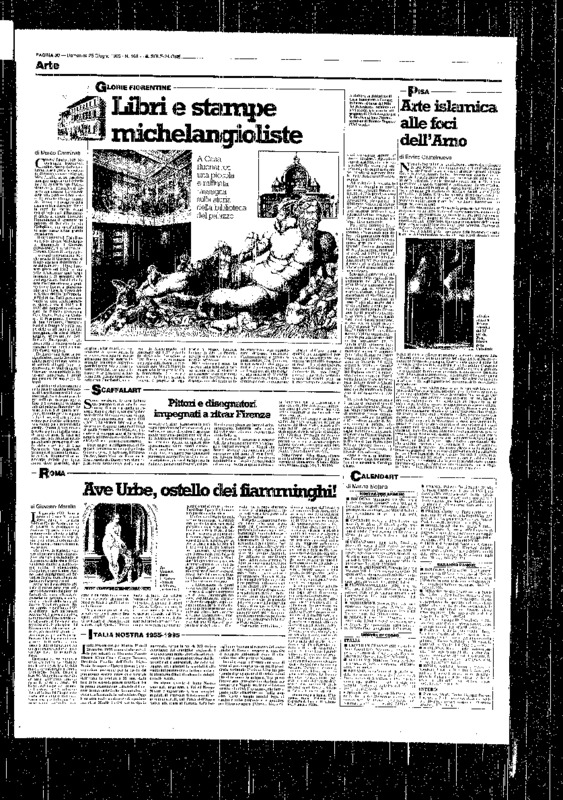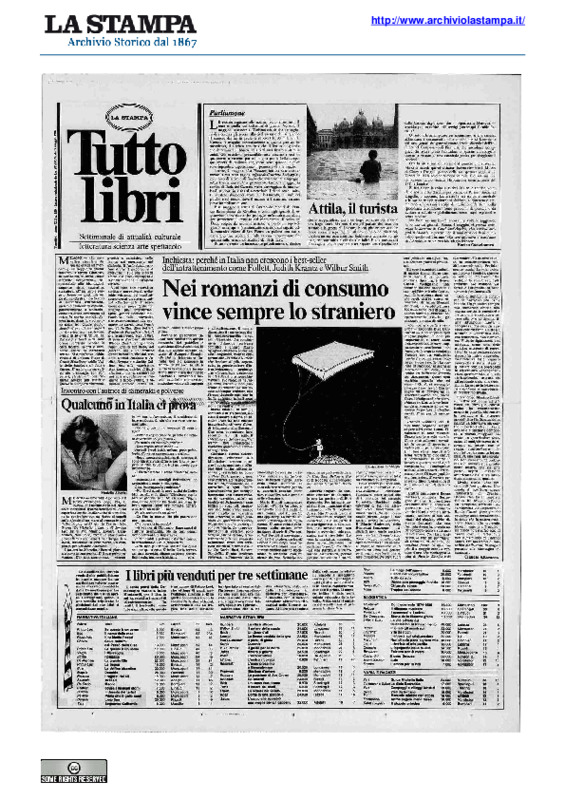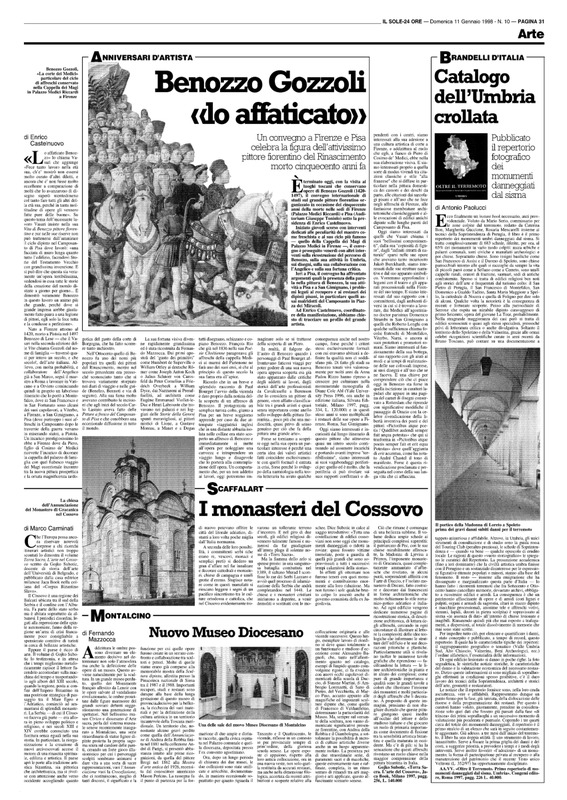Sfoglia documenti (238 in totale)
-
Accelerano i tempi e precipitano le cose
Recensione della mostra: 1900 (Parigi, Grand Palais, 14 marzo-26 giugno 2000), a c. di Philippe Thiebaut, catalogo Réunion des musées nationaux. Presentando alcune sezioni, Castelnuovo si sofferma sulla nascita dell’Art Nouveau e sulla sua diffusione in Europa, sulle tecniche artistiche, sui modelli e sui principali protagonisti. Nel contributo è richiamata la mostra Les sources du XX siècle (Parigi, Musée national d’art moderne, 4 novembre 1960- 20 gennaio 1961), organizzata dal Consiglio d’Europa.
L’articolo è introdotto da un trafiletto di Anna Detheridge, autrice della recensione dell’esposizione Art Nouveau 1890-1914 (Londra, Victoria and Albert Museum, 6 aprile- 30 luglio 2000) presente nella stessa pagina.
Una copia del catalogo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -
Al Colosseo soltanto leoni
Castelnuovo si interroga sull’utilizzo dei siti storici e archeologici per fini culturali, sollecitato dalla sentenza del pretore di Roma, Alberto Albamonte, del 10 luglio 1985. Nelle motivazioni non solo era precisato che i beni culturali dovessero essere destinati a finalità che non ne pregiudicassero la conservazione e l’integrità, ma era soprattutto sottolineato che non potessero essere concessi per scopi non pertinenti alla loro identità originaria. Diversa è la posizione di Castelnuovo, secondo cui l’attenzione è da rivolgere alla preservazione dei beni culturali e non tanto al loro carattere originario, in quanto non è raro che nel tempo abbiano cambiato più volte destinazione d’uso. Il caso della concessione della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per spettacoli teatrali, citato nell’articolo, è richiamato non tanto per i contenuti ma per i rischi che l’affollamento comporta all’edificio.
Castelnuovo prende le mosse dalla pagina che «L’Unità» dedica alla questione l’11 luglio 1985 (p. 17): il soprintendente ai Beni archeologici di Roma, Adriano La Regina, era stato accusato di abuso di potere e omissione di atti d'ufficio per avere autorizzato una rassegna cinematografica al Circo Massimo e una mostra sull’economia italiana nel Ventennio al Colosseo. Nonostante l’assoluzione, nelle motivazioni del pronunciamento il pretore – poggiando sul parere di una commissione composta da Lorenzo Quilici, Italo Insolera, Vincenzo Cabianca e Giulio Tamburini – criticava apertamente la concessione dei due siti archeologici, ritenendo le manifestazioni non compatibili con “il carattere espressivo del monumento, quale testimonianza storica e quale valore culturale [...]”. -
Albergo per fanciulli "gittati"
Recensione dell’opera: Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città, a c. di Lucia Sandri, Firenze, SPES, 1996. A partire dai risultati emersi dal libro, Castelnuovo ripercorre le principali tappe della storia dell’Ospedale, focalizzandosi sull’edificio che lo ospita, sulle opere che conserva e sul suo Archivio storico.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf". -
Architetture spirituali
Recensione dell'opera: Lina Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi, 2002. La pagina è interamente dedicata al volume e accoglie la recensione di Carlo Delcorno: Un teatro della memoria; sull’opera era già intervenuto Jader Jacobelli, Alle radici della multimedialità (XIX, 3, marzo 2002, p. 33).
Richiamando Victor Hugo ed Émile Mâle, Castelnuovo descrive la cattedrale come un “libro di pietra”, una summa illustrata della conoscenza e della fede medievale accessibile anche agli analfabeti. Bolzoni aveva evidenziato la connessione tra parole e immagini mentali nei sermoni dei predicatori tra Duecento e primo Quattrocento, paragonandoli proprio a una “cattedrale invisibile”. Pisa è presentata come una “fucina di eccezionali argomentatori”, che con le loro opere hanno tanto suggestionato anche gli artisti: il caso più emblematico è il Trionfo della Morte di Buffalmacco nel Camposanto dove gli affreschi traducono il messaggio morale trasmesso dagli stessi sermoni analizzati nel saggio. -
Argan, la ragione dell'arte
Necrologio di Giulio Carlo Argan (Torino, 17 maggio 1909-Roma, 12 novembre 1992). Per tracciare un profilo intellettuale del collega scomparso, Castelnuovo richiama gli approcci diametralmente opposti alla storia dell’arte del proprio maestro Roberto Longhi e di Lionello Venturi, con cui Argan si formò all'Università di Torino. Se il metodo di Longhi si fondava sul predominio dell'occhio e su un rapporto diretto con l’opera d’arte, all’opposto, “Argan era più portato a concettualizzare, a leggere grandi linee di tendenza, a costruire tipi e categorie. [...] insomma, erano le foreste piuttosto che gli alberi ad attirare la sua attenzione”. La migliore eredità che Argan lasciava alla storia dell’arte era proprio l’impegno a farla uscire dal suo isolamento, per dialogare con le altre discipline.
Castelnuovo menziona quelle pubblicazioni di Argan che più lo hanno colpito: di alcune è presente una copia nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”.- L'architettura protocristiana preromanica e romanica, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1936;
- L'architettura italiana del Duecento e Trecento, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1937;
- The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Perspective Theory in the Fifteenth Century, Journal of the Warburg and Courtault institutes, vol. IX, 1946, pp. 96-121;
- Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi, 1951
- Borromini, a c. Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1952;
- Brunelleschi, a c. di Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1955;
- Marcel Breuer. Disegno industriale e architettura, Milano, Gorlich, 1957;
- Salvezza e caduta nell'arte moderna. Studi e note II, Milano, Il Saggiatore, 1964 (II ed. 1968);
- Progetto e destino, Milano, Il Saggiatore, 1965 (II ed. 1968).
-
Arte islamica alle foci dell’Arno
Recensione della mostra: Arte islamica. Presenze di cultura islamica nella Toscana costiera (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 28 maggio-30 giugno 1995). -
Assisi ha un cuore fragile
Castelnuovo interviene sulle vetrate della Basilica di San Francesco d’Assisi, in occasione della pubblicazione dello studio di Frank Martin, Le vetrate di San Francesco in Assisi. Nascita e sviluppo di un genere artistico in Italia (corredato dalle fotografie di Gerhard Ruf; Assisi, 1998). Sin dal titolo, l’articolo sottolinea la fragilità di queste opere, scampate alla distruzione del terremoto nel 1997 ma ancora in attesa di un intervento di restauro, ripercorrendo le tappe del cantiere assisiate e soffermandosi sul rapporto tra la pittura su vetro e gli affreschi e tra pittori e maestri vetrai.
Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf". -
Attila, il turista
Castelnuovo interviene sulla tutela del patrimonio culturale, spronato dai quotidiani nazionali che con grande enfasi avevano ripetutamente denunciato nei primi giorni di maggio il problema del turismo di massa (a Venezia e Firenze) e i danni arrecati dai vandali ai monumenti. Come suggerisce il titolo, l’intervento ribadisce l’urgenza di ragionamenti ben più ampi sulla salvaguardia dei beni culturali, capaci di individuare e affrontare i fattori di rischio (ad esempio l’inquinamento atmosferico delle città che ogni giorno attacca silenziosamente le superfici lapidee).
L’articolo richiama questioni affrontate in altri contributi, come la soluzione di creare delle copie per tutelare i siti più visitati: Castelnuovo aveva già presentato la soluzione della Grotta di Lascaux e della Camera degli Sposi di Mantova, ricostruita a Londra per l’esposizione Splendours of the Gonzaga (nel 1981 aveva recensito la mostra: Fuochi d’artificio dei Gonzaga a Londra; si vedano inoltre: Contro feticci e miti dei capolavori d’arte; Non disturbiamo i bisonti di Altamira). -
Beati i poco intelligenti
Recensione dell’opera: Cesare Garboli, Falbalas. Immagini del Novecento, Milano, Garzanti (Saggi blu), 1990; il contributo segue la recensione di Geno Pampaloni: Scrittore prestato alla critica. Falbalas, il cui titolo è tratto dal film di Jacques Becker del 1945, raccoglie saggi su letterati del Novecento italiano, quali Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Sandro Penna, Giovanni Delfini e Roberto Longhi (quest’ultimo contributo riprende Via il genio, via la poesia – del 1969, sulla mostra di Rembrandt al Rijksmuseum di Amsterdam – ampliandolo con una selezione di inediti longhiani). A partire dalla lettura che Garboli offre della pittura, Castelnuovo torna sul rapporto dell’autore con Longhi, presentato come “mago” della critica d’arte (già ne aveva parlato recensendo la Breve ma veridica storia della pittura italiana: La giovinezza del Corsaro Nero).
L’articolo è riedito nella raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000, pp. 144-146). -
Benozzo Gozzoli "lo affaticato"
Castelnuovo traccia un profilo di Benozzo Gozzoli focalizzato sulla sua fortuna critica tra XIX e XX secolo, a partire dal proprio intervento presentato al convegno dedicato al pittore nel cinquecentesimo anniversario della morte: Benozzo Gozzoli. Viaggio attraverso un secolo (Firenze, Palazzo Medici Ricciardi; Pisa, Auditorium dell’Opera della Primaziale Giuseppe Toniolo, 8-10 gennaio 1998), atti del convegno a c. di Enrico Castelnuovo e Alessandra Malquori, catalogo Pacini (2003).
Il programma dell’evento, parte dell'archivio privato di Castelnuovo, segnala che egli ha moderato la prima sessione in cui è intervenuto: il titolo del contributo, che apre il volume degli atti, è Benozzo 1997. Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf".